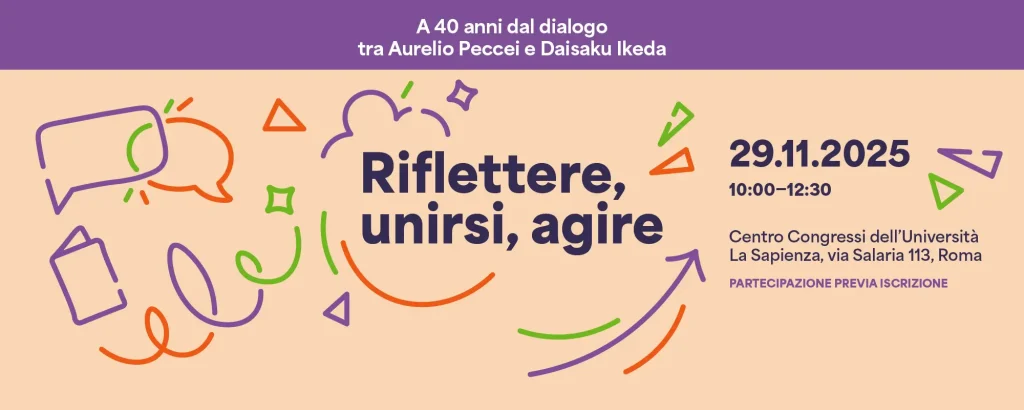Intervista a Giangiorgio Pasqualotto
di Roberto Minganti e Giuliomario Rampelli – DuemilaUno n. 67 – anno 1997
«Profonda è l’ignoranza in materia di pensiero indiano; per la mente moderna la filosofia indiana si riduce a due o tre “sciocche” nozioni sulla maya, o il carattere illusorio del mondo, sul karma, ossia il credere nel destino, e sul tyaga, o il desiderio ascetico di liberarsi dalla forma corporea». Sono parole con cui Sarvepalli Radhakrishnan, uno dei più autorevoli studiosi del pensiero indiano, nella prefazione della sua monumentale opera di 1500 pagine, punta il dito sulla superficialità con cui spesso gli occidentali entrano in contatto con il pensiero dell’India e – aggiungiamo noi – con la filosofia orientale in genere. In un’epoca in cui tutto viene ridotto a oggetto di rapido consumo, anche il Buddismo corre questo rischio: new age, mass-media, star system, supermarket dello spirituale, tendono a liofilizzare l’insegnamento del Budda facendolo apparire come un gioco da ragazzi. In questo contesto Illuminismo e Illuminazione, l’ultima fatica di Giangiorgio Pasqualotto – professore di Filosofia all’Università di Padova – ci porta «a riscoprire i centri propulsivi della potenza razionale buddhista».
Dopo gli studi filosofici, come è arrivato a interessarsi di Buddismo?
Ci sono stati due ordini di motivi. Uno di carattere filosofico: mi interessava la filosofia critica e mi ero già occupato di teoria critica della società – Adorno, Horkheimer, Benjamin e di Nietzsche. In questo orizzonte, alcuni grandi discorsi del Budda – specialmente quello rivolto ai Kalama – mi sono apparsi come dei veri e propri manifesti del pensiero critico. Il secondo ordine di motivi è relativo alla connessione tra etica e conoscenza. Il binomio tra prajna (saggezza) e karuna (compassione), così forte in tutti i discorsi del Budda, mi aveva colpito in modo particolare. Nella tradizione occidentale, invece, questi due concetti sono quasi sempre stati considerati in modo separato.
Forse nel pensiero greco ci sono tracce di questo modo di pensare.
Sì, nella filosofia greca ci sono stati degli spunti interessanti, penso a Epicuro, Pitagora o allo stesso Platone. Ma nella filosofia moderna e contemporanea la connessione tra conoscenza e pratica etica è debole, anche se troviamo molti appelli e la volontà di superare questo distacco: penso a Rousseau, a Marx, a Benjamin. Però sono rimasti sempre e solo dei discorsi. Invece nei Sutra ho trovato una chiara indicazione su ciò che ritengo il vero luogo di svolta: la pratica meditativa. Quindi non solo un discorso di mediazione tra teoria e prassi, ma una costante verifica, anche in negativo, dei processi e dei progressi fatti nella comprensione. Ovviamente questo comporta che la verifica dei progressi non sia solo soggettiva, ma anche in rapporto al comportamento con gli altri.
Qual è nel Buddismo il punto di raccordo tra etica e conoscenza?
Ciò che secondo me le unisce è la teoria dell’anatta (non-sostanzialità dell’io), ma ritorneremo su questo punto che trovo assolutamente centrale.
Lungo la mia ricerca c’è sempre stato un interesse teoretico, un interesse etico, ma anche un interesse estetico: il mio lavoro sull’estetica del “vuoto” era motivato da quello stile che, particolarmente in Giappone, è stato determinato e influenzato dal Buddismo. Da giovane, lettore entusiasta di Feuerbach, le prime volte che ho incontrato i Discorsi del Budda mi sono veramente esaltato adolescenzialmente: la prima cosa che mi era saltata agli occhi era questa etica senza teologia. Le mie due matrici extraeuropee furono il Daodejing che, letto in senso anarchico, mi apparve come un grande manifesto libertario – e il Dhammapada (scrittura del Canone Pali, raccolta di 423 versi che comprendono un sistema etico, ndr) – che vidi come un grande manifesto contro le classi e contro le teologie positive. Ovviamente in seguito mi sono reso conto che né il Taoismo né il Buddismo sono “contro”, per cui ho rivisto e corretto questo mio atteggiamento sentimentale e passionale.
Lei fa riferimento a una tradizione buddista particolare?
I miei due poli di riferimento sono il Canone Pali e lo Zen. Credo che nel Canone Pali ci siano già tutti gli elementi utili per ogni scuola buddista. Questa convinzione forse non è del tutto giustificata, però allo stesso modo penso che in Platone ci sia già il 90 per cento di tutta la filosofia occidentale. È come se una persona volesse avvicinarsi al Cristianesimo: la prima cosa che farebbe è leggere la Bibbia e i Vangeli. Così ho fatto anch’io per il Buddismo. All’inizio, però, la cosa che mi ha colpito di più era l’enfasi posta sul comportamento, per questo mi sono interessato allo Zen. Anche in questo caso ci sono state coincidenze casuali: ho conosciuto il maestro Engaku Taino dello Zen Rinzai. In particolare poi mi sono avvicinato allo Zen Rinzai perché, occupandomi anche di Logica, mi interessavano i koan, i paradossi logici.
Qual è la caratteristica più evidente dell’etica buddista e si può parlare di un’etica buddista o di più etiche buddiste?
Secondo me c’è un nucleo molto forte che è quello scolasticamente contenuto nell’Ottuplice sentiero. Credo però che il vero aspetto rivoluzionario – e può essere che altri studiosi non siano affatto d’accordo con me – sia proprio la teoria dell’anatta, questa idea del non-sé. Se ci limitiamo solo all’Ottuplice sentiero, rischiamo di farlo diventare qualcosa di equivalente al Decalogo. Il problema non è tanto parlare delle cose giuste o sbagliate che una persona dovrebbe fare per raggiungere il benessere. Qui ci troviamo di fronte a qualcosa di ancora più radicale – per questo secondo me l’etica buddista è la più difficile di tutte: mettere in discussione il concetto stesso di Io, di identità. Questo è il punto forte. Dobbiamo capire che esistiamo solo in relazione ad altro. Questo “altro” sono le cose, gli animali, le piante, i minerali: tutto ciò che è esterno a noi, compresi, ovviamente anche gli altri individui.
È messo in discussione, quindi, il concetto stesso di individualità.
Certo, si arriva a un punto tale per cui non c’è più un individuo “che si pone in rapporto con altri individui”; così il precetto cristiano “ama il prossimo tuo come te stesso” diventa problematico perché il “te stesso” è messo in discussione. Allora non si può più parlare di etica in termini tradizionali, perché l’etica tradizionale dà per scontato che ci sia un individuo “in rapporto” ad altri individui, che ci sia una persona che prima è “persona” e poi si mette in relazione – positiva o negativa – con altri che sono “individui” separati. Il Buddismo pone invece una questione radicale: io non sono qualcuno se non in rapporto ad altri. Ma quando parlo di “in rapporto ad altri” non voglio dire che io sia costituito come individuo “prima” di entrare in rapporto con altri, ma che io “sono costituito dalle relazioni con gli altri”. Questo è un punto critico perché quasi del tutto estraneo alla tradizione occidentale: forse solo Platone, alla fine del Sofista, vi si avvicina.
Tentiamo di spiegarlo più semplicemente.
Mettiamo il problema in termini di logica: non ci sono due termini e poi la relazione che mette in rapporto i due termini, ma ogni termine si costituisce nella relazione. Provate a pensare a due termini indipendentemente dalla relazione che li unisce: è impossibile. Anche prendendo due cose opposte – bianco e nero – nel momento stesso in cui pensiamo bianco, dobbiamo pensarlo in relazione al nero. Ciò non vale solo per la logica, ma anche per la fisica. Facciamo un esempio biologico, l’embrione: quando l’embrione è qualcosa di realmente indipendente in rapporto ad altro? Mai. Nasce da un rapporto di due fattori, poi il suo sviluppo è costantemente determinato da ciò che lo circonda, da una serie multipla di relazioni – l’aria, l’acqua, l’ossigeno, tutti i composti chimici che formano il nutrimento placentare. Quindi anche se prendiamo in considerazione l’aspetto materiale della realtà, questa intuizione dell’anatta si rivela assolutamente formidabile.
Purtroppo è stata per parecchio tempo identificata con la posizione nichilista.
È vero. Dicevano che nel Buddismo non esiste l’individuo, che il Buddismo è anti-individuale, che è nichilista. Invece è esattamente l’opposto, nel senso che ogni individuo è infinitamente ricco in quanto costituito da una rete infinita di relazioni. Cerco sempre di inventarmi delle metafore, anche per spiegarlo ai miei studenti: la migliore che sono riuscito a trovare è quella del nodo. Un nodo in sé non è nulla. È nodo perché ci sono dei fili che si incrociano e si aggrovigliano in un certo modo. Ma se togliamo i fili che lo compongono, il nodo non esiste più. Il nodo, poi, può essere pensato come qualcosa di dinamico: se infatti muoviamo uno dei fili, di conseguenza si muovono tutti gli altri. Quindi il cambiamento di un componente provoca una reazione in tutti gli altri costituenti. Ma in ogni caso quello che a me interessa è che il nodo in sé non esiste, esiste solo come insieme di relazioni. Un individuo quindi non “entra in relazione”, ma “è” relazione. Non esiste un individuo prima della relazione e neanche dopo…
E la morte?
È un mutamento di qualità di relazioni. Non sei più in relazione con i vivi, ma con altre cose. Provocatoriamente agli studenti chiedo di mostrarmi qualcosa che non sia in relazione: ovviamente non ci riescono. Il senso comune nostro, ma anche di molti filosofi della tradizione occidentale, ci spinge a pensare le cose come separate. Allora qui bisognerebbe giocare un po’ con il linguaggio e dire: le cose sono distinte, ma non separate. Altrimenti si potrebbe pensare che siano un tutt’uno, una specie di amalgama indifferenziato. Questo punto di vista è stato molto spesso imputato alla gnoseologia buddista. Ciò è successo grazie anche alla beat generation che ha assunto gli elementi più superficiali del Buddismo, permettendo che tale equivoco passasse a livello di massa. Ricordo degli scritti di Ginsberg che lasciavano spazio a queste interpretazioni. Il problema che ci troviamo di fronte, invece, è quello di capire che tutto è relazionato, ma per vedere così bisogna saper fare le distinzioni: io so perfettamente che questo è un libro e che questo è un tavolo, ma devo sapere anche che posso distinguerli solo perché sono in relazione.
Una volta data questa impostazione di fondo, passiamo ad analizzare più da vicino alcuni aspetti dell’etica buddista: per esempio la distinzione classica tra arhat e bodhisattva. Fanno capo a una visione comune o sono in effetti due visioni etiche diverse?
È una domanda difficile. Per rispondere bisognerebbe avere una conoscenza profonda della storia del Buddismo che io non ho. Non so se esistano documenti che ci testimoniano che l‘arhat, una volta raggiunto il risveglio, si disinteressa degli altri, abbandona i suoi amici, il mondo e se ne va. Così come dovremmo avere tutte le prove che il bodhisattva invece fa il contrario.
Dicendo che l’arhat non rinasce, sembra che in un certo senso effettivamente si disinteressi agli altri.
Ci sono vari problemi. È scritto effettivamente che l’arhat una volta conseguito il proprio Risveglio non si interessa più degli altri. Io sono convinto, però, che se uno raggiunge il Risveglio – indipendentemente dal fatto che voglia o non voglia aiutare gli altri – di fatto li aiuta lo stesso, nel senso che è di aiuto grazie al suo Risveglio. Nelle tradizioni cristiane ci sono i santi, che fanno il bene proprio perché non pensano più di farlo, perché hanno abbandonato i riferimenti bene/male. Fanno il bene automaticamente, senza nessun calcolo, senza avere nessun fine. Il Nirvana è l’estinzione dell’attaccamento all’Io, e questo raggiungimento si deve rispecchiare nella vita, quindi l’arhat non farà intenzionalmente il bene, ma si comporterà spontaneamente nel migliore dei modi possibili automaticamente. Anche il bodhisattva, in questo senso, è un equivalente dell’arhat ed è stato enfatizzato dai mahayanisti per distinguersi, secondo me, dall’ Hinayana. Per dimostrare che, in fondo, la loro intenzione era quella di aiutare più persone. Ma questo, secondo me, è un livello di religiosità superficiale, utilizzato – per dirla in modo brutale – per acquisire seguaci, per dire «siamo più bravi, ci interessiamo di più alla gente e non siamo così aristocratici come loro». Se andiamo alla sostanza delle caratteristiche l’arhat e del bodhisattva, vediamo che sono le stesse. Credo che siano quindi distinzioni puramente culturali e storiche.
L’ultima tentazione del demone Mara a Shakyamuni è stata comunque quella del suicidio per raggiungere il Nirvana.
Questa è la vera tentazione nichilista. Oggi il Nirvana, dal ragazzino eversivo, è visto come abbandono nichilista. Nirvana non vuol dire estinzione della vita, ma estinzione dell’attaccamento alla vita, così come è estinzione dell’attaccamento alla non-vita: è estinzione di ogni forma di attaccamento all’Io come anche alla soppressione dell’Io. Quindi colui che ha raggiunto il Nirvana dovrebbe in realtà vivere come tutti gli altri, ma senza gli odi, le passioni, le ansie e le recriminazioni che turbano la mente dei comuni esseri umani. Cosa diversa è il Paranirvana che comporta anche la morte fisica.
Mi era sembrato di capire che l’arhat prima di poter aiutare gli altri vuole sviluppare la saggezza per farlo, e che il bodhisattva, invece, proprio per ottenere quella saggezza deve prima aiutare gli altri.
Sono due estremizzazioni sbagliate sulla base di quello che dice il Canone. Il Canone afferma che saggezza e compassione devono andare sempre di pari passo.
Allora qual è il senso di questa vicinanza tra prajna e karuna?
Non è vero né che uno deve diventare prima sapiente e poi buono, né viceversa. I due aspetti dovrebbero procedere paralleli: quanto più capisco che le cose sono insostanziali, impermanenti e tutte attraversate dal dolore, tanto più vado avanti a sperimentarlo in me, negli altri, nelle cose, procedendo nella compassione. Prendiamo l’esempio tratto dal Canone a proposito del monaco che viene attaccato dai banditi. Dice Shakyamuni: se tu vieni attaccato dai banditi e questi cominciano a tagliarti prima un piede, poi l’altro e così via, cosa devi pensare? Devi pensare: questo piede non sono io, questa gamba non è mia, quest’altro piede non mi appartiene. Ciò vuol dire che tutta la mia identità non si risolve nel piede, nella gamba ecc. Ovviamente questo è un esempio estremo, vuol dire che tu puoi resistere alla sofferenza nella misura in cui sei profondamente convinto che nulla ti appartiene. Per fare questo è chiaro che tu non devi più avere il concetto di un Io come “fortezza” da difendere e consolidare.
Questo esempio, oltre a essere una metafora, è anche un caso estremo, ma nella vita quotidiana cosa succede?
Certo qui si parla di estremi, ma si può cominciare dalle cose più semplici: qual è l’antidoto all’attaccamento? È il dono: tu tieni tanto a una cosa? Allora per verificare quanto sei libero dall’attaccamento la regali. E il regalo diventa quasi un esercizio spirituale. Questo atto, che è un esercizio pratico, consente anche una maggiore comprensione: nel dono disinteressato si comprende che non c’è un io che dona.
In questo modo un buddista non corre il rischio di diventare un “troppo buono”, o di sbilanciarsi da una parte sola?
Proprio per questo motivo è fondamentale l’upekka, l’equanimità. Perché se uno fa il “troppo buono” diventa anche un po’ stupido. E non lo diventa solo soggettivamente, ma anche oggettivamente perché non ottiene alla fine il risultato di aiutare. Se, ad esempio, regalo una lira a tutti, alla fine non aiuto nessuno. È molto meglio individuare un gruppo preciso e aiutare quello. Certo sono cosciente di aver fatto una discriminazione, e corro il pericolo di attaccarmi a quella parte che ho aiutato pensando che sia il tutto. Quindi – per usare una metafora – bisognerebbe avere la capacità di mettere a fuoco un primo piano e lì esercitare la compassione in maniera precisa, ma senza dimenticare che quel primo piano viene fuori da uno sfondo che continua a esserci. Quindi anche se aiuto un gruppo specifico, lo faccio sapendo che continuano a esserci altri gruppi che hanno bisogno di aiuto. Un altro esempio è quello del medico: se un medico cura in maniera troppo entusiasta, viene travolto dal dolore dei suoi pazienti, se si mette a piangere quando opera, non riuscirà mai a salvare nessuno. Deve quindi sviluppare un certo distacco nel rapporto con il paziente.
Qui introduciamo un altro aspetto dell’etica buddista, la quale non fa riferimento tanto al bene e male, quanto al benefico e nocivo. Quali sono le conseguenze pratiche di questo punto di vista?
A noi potrebbe sembrare una diminuzione – pensiamo al Sommo Bene di cui parla Kant – invece siamo in presenza della bontà praticata in base ai risultati che produce per cui non si può mai avere un parametro assoluto. La critica che può essere mossa a questo punto di vista è quella del relativismo o dell’opportunismo, ma di nuovo viene fuori la centralità dell’anatta. Si può parlare di opportunismo soltanto se hai l’ipotesi ancora vigente di un Io, di un’unità – che sia un individuo, uno stato, una nazione – a cui far riferimento, a cui qualcosa è opportuno, a cui qualcosa è relativo. Ma se prendiamo come punto di riferimento l’anatta, allora non c’è spazio per nessuna critica. Se invece manteniamo l’individuo, lo stato o la nazione come parametro, è chiaro che il discorso dell’efficacia può venir relativizzato in senso individualistico. Ma la verità è che esiste l’azione e non l’agente: intuizione e frase rivoluzionaria, innovativa perché noi siamo tutti cresciuti in occidente con l’idea che la cosa principale è l’agente e non l’azione. In occidente c’è l’enfasi di dire «Sono io che ho fatto questo!», c’è l’enfasi sul riconoscimento di chi fa l’opera buona. Chi – in occidente – farebbe un’opera buona se non ci fosse il riconoscimento? Questo stesso atteggiamento si trova nell’arte: ai miei studenti tento di spiegare perché molti artisti orientali non firmavano. Proviamo a pensare a un pittore occidentale che non firma, è impensabile. Anzi nell’arte moderna il riferimento all’individuo è maggiore di quanto non lo fosse nell’antichità. Solo nei grandi mistici cristiani c’è l’abbandono del soggetto: non ha importanza per loro che l’azione buona sia stata fatta da X o Y, l’importante è che l’altro sia salvato.
Credo che nelle tradizioni mistiche di tutte le religioni ci sia questo atteggiamento, penso a Martin Buber, a Meister Eckhart o ai Sufi.
Certamente, perché l’attaccamento all’Io è la radice di tutti gli attaccamenti. La seconda e la terza nobile verità predicate da Shakyamuni sono importanti: qual è la causa della sofferenza? È il desiderio. Ma qual è la radice del desiderio? È l’Io. Ora se noi intacchiamo – relativizzandolo nello spazio e nel tempo – questo Io, intacchiamo la radice del desiderio e, quindi, la radice della sofferenza. È un discorso così chiaro che molte volte mi sembra fin troppo facile. Ma quando proviamo ad applicarlo nella vita quotidiana, ci rendiamo conto che invece tutto procede secondo una logica opposta, e la faccenda si fa complicata.
Quindi cadono tutte le costruzioni basate sulla dicotomia lo/Altro, egoismo/ altruismo ecc.
Certamente, addirittura non può valere neanche altruismo/egoismo. Ogni Io è già costituito da altro. Provocatoriamente ho intitolato un mio scritto recente: “l’Io come sangha” (la comunità buddista, ndr). L’Io si può “associare” a una comunità ma, a ben vedere, non “entra” in una comunità, perché di per sé è già una comunità. L’individuo non esiste se non è figlio, padre, fratello, ecc., di qualcuno. Supponiamolo completamente isolato, come Tarzan, anche in tal caso non sarebbe tale se non in relazione alle liane, a Chita… Tutto questo è comunque troppo facile a dirsi, ma molto difficile da applicare nella vita quotidiana.
I precetti vengono spesso associati all’etica, ma può essere semplificato così il discorso etico?
La vecchia metafora della zattera o della scala qui va molto bene. I precetti sono strumenti in vista della riduzione dell’attaccamento. Se questi strumenti, o mezzi, vengono interpretati come fini, allora si cade nel ritualismo, nel formalismo, nell’attaccamento alle formule. Questo vale per tutte le religioni. Anche nel Cristianesimo, se uno è attaccato ai Dieci Comandamenti in maniera ossessiva, va benissimo perché non ucciderà, non ruberà ecc. ma può anche diventare un legalista, un fariseo. Ha scambiato gli strumenti per il fine. Questi strumenti, però, possono essere abbandonati solo dopo che sono stati usati, non prima. Perché ci sono i furbi che pensano: «Se i precetti sono solo uno strumento allora tanto vale non seguirli. Ma la scala serve per portarti in alto, e la zattera serve per condurti al di là del fiume, ma in cima o al di là del fiume bisogna arrivarci. Se poi, dopo che sei arrivato, te la porti ancora dietro, allora sei stupido. Quindi questi strumenti devono essere usati: per esempio la “retta azione” va fatta. Quando si potrà abbandonarla? Quando tale precetto sarà talmente incorporato e automatico che non dovrai più fare riferimento a esso. Un artista, un pianista, un danzatore fa gli esercizi per anni; poi, se raggiunge certi livelli, quei passaggi di note o di danza non li applica, li fa e basta. Anzi, se suonasse o danzasse pensando di eseguire qualcosa, si capirebbe e si vedrebbe l’impaccio. Quindi, in termini etici, si dovrebbe fare il bene talmente tante volte e talmente con tanta passione, che alla fine non ci si accorge più di farlo e lo si fa spontaneamente. Noi abbiamo l’idea che i precetti siano qualcosa solo di coercitivo, e lo sono se ci si ferma, se non li si considera come mezzi. L’esercizio – il solfeggio ad esempio – è coercitivo se uno si ferma tutta la vita a solfeggiare.
C’è una differenza tra l’idea dei precetti nel Buddismo e l’insieme di regole delle religioni rivelate nelle quali la regola è la parola di Dio?
Io non mi azzarderei a dare risposte su questo perché non sono un esperto e poi delle altre religioni mi interessano solo i nuclei delle tradizioni mistiche. Quindi è vero che i comandamenti si rispettano per amor di Dio, ma questo può voler dire rispettarli pensando a qualcosa che va al di là degli stessi comandamenti – in una situazione che è simile a quella della zattera. Se invece la lettura è di tipo autoritario, pensando a un Dio-persona che se non faccio le cose giuste mi bastona e se faccio quelle giuste mi premia, allora cadiamo nella situazione denunciata da Meister Eckhart, nella quale si usa Dio come una mucca o una pecora: lo si prega per mungerlo, per ottenere qualcosa in cambio. Fai il bene perché hai paura della sua punizione o speri nella sua ricompensa.
Ma questo non è il vero bene, perché il vero bene – diceva Eckhart – è senza “perché”. Senza perché vuol dire che non c’è un fine: lo fai perché sei libero da qualsiasi costrizione a farlo. Ma, per farlo così, ti devi essere esercitato a farlo.
Pensando al karma o alla legge di causa-effetto, non si potrebbe ricadere in una sorta di agire bene per paura di una punizione?
Ci potrebbe essere questa caduta, sia in occidente sia in oriente, in una versione popolare del Buddismo. Se una persona si comporta bene solo perché ha paura di rinascere come rospo nella vita successiva, siamo all’interno di quella logica. Una proiezione escatologica, finale, c’è anche nei discorsi divulgativi sul karma. Ho la netta sensazione che tutta questa enfasi posta sul karmasia al 90% di matrice occidentale, per le nostre manie di esorcizzare la morte e il post-mortem. Il karma, quindi, viene considerato come una specie di polizza assicurativa esattamente come il giudizio universale. Se invece facciamo riferimento rigoroso ai testi e alla tradizione – buddista o induista – si può vedere molto chiaramente che lo scopo è quello di uscire dal ciclo delle reincarnazioni, imposto dalla legge di causa-effetto – anche se si sa che questa legge funziona sempre. E per uscire bisogna essere capaci di estinguere l’attaccamento. Perciò è necessario sapere che nel karmaè assente il concetto di retribuzione morale, che il karmaè una legge fisica come la legge di gravità.
Nel suo libro c’è un capitolo molto originale sul sangha. Quali aspetti della vita comunitaria sono importanti per l’ideale etico del Buddismo?
Non vorrei essere ripetitivo, ma credo che il nucleo fondamentale sia sempre quello della relativizzazione dell’Io. In realtà una comunità, ma addirittura io stesso come individuo/comunità, non riesco a capirmi e a vivere come comunità se non abbasso la soglia della “sostanzialità” e della “permanenza”. Se in una comunità ciascuno cerca di capire e praticare anatta (non-sostanzialità) e anicca (impermanenza), allora è fatta. Ma è una formula difficilissima da praticare. Tanto che finora di sangha funzionanti non ne ho mai visti. Dai miei primi esperimenti con i cattolici, fino ai più recenti con amici di comunità buddiste, ho imparato che la strada da fare è ancora molto lunga. Vedo sempre resistenze fortissime: i problemi che nascono in tutte le comunità – anche nelle migliori – derivano da residui di quella malattia che si potrebbe chiamare “ipertrofia dell’io”.
Intorno a Shakyamuni però si era creato un sangha funzionante.
Funzionante come numero, ma, leggendo i sutra, lui spesso diceva ai monaci che non avevano capito nulla. Nel senso che doveva sempre correggere il loro atteggiamento.
Ma non le sembra invece che proprio questo continuo processo di miglioramento personale-insieme-agli-altri, sia la caratteristica di un sangha? E secondo lei il Buddismo in occidente non dovrebbe dire qualcosa di nuovo proprio sul piano della vita comunitaria, o – per dirla in termini più ampi – della convivenza civile?
Certo, è un processo lento, ma essenziale. Bisogna evitare quegli errori che hanno una matrice comune nell’egocentrismo. Ma si può correre anche il pericolo opposto: quello di dire che siamo tutti non-egocentrici. Non è sufficiente dirlo, bisogna metterlo in pratica. Lì rinasce il conflitto: però un conto è esser prigionieri del conflitto e un conto è capire che questo conflitto può essere l’occasione per modificare i termini stessi del conflitto. Trasformare quei termini significa non pensare più che deve essere l’altro e non io a cambiare, perché io ho sempre ragione.
Nello schema che propose a Milano, Galtung metteva in relazione il conflitto con anatta.
Certo, quello schema era giusto. L’ anatta non puoi praticarla dal punto di vista di un solo termine del conflitto. Paradossalmente anche se ti sposti troppo dalla parte del nemico – se fai troppo l’altruista – non fai altro che ribadire e rinforzare la sostanzialità esterna. Comunque ci sono grandissimi problemi nel portare avanti una comunità, proprio perché anche il lavoro di riduzione dell’ego può sempre capovolgersi nel suo contrario.
Questi problemi non si possono ricondurre all’interno della comunità ed essere considerati come un aspetto importante della comunità stessa?
Sì, ma può uscire fuori anche una forma di egocentrismo di gruppo, una specie di orgoglio di sangha. Pensare, cioè, che il nostro gruppo sia più bravo degli altri. Ne ho visti tanti di questi orgogli di comunità.
La prospettiva che lei poneva nel libro è quella di un sangha cosmico.
È quella in cui il sangha non c’è più. Qui vale lo stesso discorso dei precetti: il sangha è necessario, ma come strumento, altrimenti assume le caratteristiche di una setta. Gli anarchici – ad esempio – sono contro ogni comunità organizzata, ma cosa deriva da questo? Che proprio la loro idea di assenza di comunità finisce col rinforzare l’individualismo. Invece di andare avanti, tornano indietro. Siccome non c’è possibilità di nessuna comunità perfetta allora diventa perfetto l’individuo. I miei amici anarchici sono i più grandi individualisti che io abbia mai visto, come il loro “maestro” Stirner. Quindi, prima di negarlo, il sangha va utilizzato, bisogna utilizzare forme sempre più ampie di sangha. Dovrebbe diventare una comunità che si “gonfia” sempre di più (non in senso di importanza, ma di estensione) fino a che “scoppia”, finché non ha più senso il suo esistere come realtà separata.
Galtung, quando sottolinea i punti deboli del Buddismo, sottolinea la sua eccessiva tolleranza che lo ha portato a essere anche debole verso regimi autoritari. Qual è la sua opinione in proposito?
Storicamente talvolta è stato così, come, per esempio, in Birmania.
Ma questo è un pericolo che può correre il Buddismo anche in occidente?
È un problema colossale. Non so bene come se ne possa uscir fuori. È un problema simile a quello sulla liceità dell’uso dei mass-media: usarli, ma con il rischio di farsi inglobare da loro. La via di mezzo potrebbe essere quella di usare tutti gli strumenti della società contemporanea senza lasciarsi catturare da essi. La frase di Galtung mi aveva in parte trovato d’accordo, ma mi aveva anche fatto riflettere in senso contrario, considerando che i tibetani non sono affatto rimasti passivi nei confronti della Cina.
È un esempio isolato però, se pensiamo al sostegno che il Buddismo giapponese ha dato ai militaristi prima e durante la seconda guerra mondiale, o alla lotta contro i Tamil nello Sri-Lanka.
Lì in Giappone c’erano interessi economici, di sopravvivenza, e quando entrano in campo quegli interessi la religione scompare. Quando compare il denaro scompare la spiritualità. Perfino il Taoismo, quando è diventato religione di stato, ha smesso di dare contributi filosofici originali. Comunque quando si affrontano i problemi storici è difficile dare una definizione generale, perché esiste sempre un caso contrario. Ad esempio la via dei buddisti thailandesi è quella di evitare il conflitto con il regime militare, ma anche quella di non trasformarsi in servi di quel regime. Cercano di dare aiuto alle vittime. Certo, così non si risolve granché, ma intanto non si offre un appoggio formale ai generali e alleviano delle sofferenze. Ritornando al discorso di Galtung, in parte è condivisibile, ma non mi sentirei di dire che il Buddismo è stato sempre morbido, nel senso di remissivo: i Tibetani pur in modo non violento, combattono.
Credo che Galtung intendesse dire anche a noi buddisti occidentali di far sentire la nostra voce nella società, di non rimanere indifferenti a quello che ci succede intorno.
In questo ha veramente ragione, altrimenti c’è l’attaccamento al sangha, c’è una specie di sangha-mania. Star bene in campagna, tra le pecore, gli ovetti, i formaggi… e allora veramente si arriva a quella squallida interpretazione individualista dell’arhat di cui si parlava all’inizio.
È difficile parlare di felicità, sembra quasi che ci sia un muro intorno a questa parola. Cosa vuol dire per lei essere felice?
È il distacco. Ma non nel senso della fuga dalla società o dalla vita. Distacco nel senso che si trova nell’adagio che vale per tutti i mistici: essere nel mondo, ma non del mondo. Questa, credo, sia l’autentica “via di mezzo” buddista. Gioire e soffrire, ma senza cadere vittime della gioia o del dolore. Così, mi rendo conto, rinnego gran parte della mia tradizione occidentale, percorsa di grandi amori e di grandi odi. Ma c’è anche una parte – non proprio tanto piccola – di questa tradizione a cui mi sento di appartenere: quella ad esempio di Epicuro e di Spinoza, “bodhisattva” inconsapevoli. In definitiva vorrei dire: felicità come distacco anche dall’ossessione della ricerca della felicità.
Giangiorgio Pasqualotto (1946-2025) si è laureato in filosofia sotto la guida di Massimo Cacciari nel 1969. Ha studiato Filosofia analitica all’Università di Edimburgo, e Teoria critica della società a Francoforte. Ha insegnato Letteratura artistica all’Università di Venezia ed Estetica all’Università di Padova. Ha insegnato Storia della Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova. Nel 1993 è stato tra i fondatori, a Venezia, del Centro Maitreya per lo studio del pensiero e della cultura buddhista.È stato tra i promotori del Master in Studi Interculturali dell’Università di Padova
Ha collaborato a varie riviste, tra le quali Contropiano, Angelus Novus, Il Centauro, Nuova Corrente, Aut Aut, Paramita.
Principali pubblicazioni
- Avanguardia e tecnologia. Walter Benjamin, Max Bense e i problemi dell’estetica tecnologica, Roma, Officina, 1971;
- Teoria come utopia. Studi sulla Scuola di Francoforte (Marcuse, Adorno, Horkheimer), Verona, Bertani, 1974;
- Storia e critica dell’ideologia, Padova, CLEUP, 1978;
- Oltre l’ideologia: «Il Federalista», Roma, Ist. dell’Enciclopedia Italiana, 1979;
- Pensiero negativo e civiltà borghese, Napoli, Guida, 1981;
- Saggi di critica, Padova, CLEUP, 1981;
- Saggi su Nietzsche, Milano, Franco Angeli, 1985;
- Il Tao della filosofia. Corrispondenze tra pensieri d’Oriente e d’Occidente, Parma, Pratiche, 1989;
- Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Venezia, Marsilio, 1992;
- Illuminismo e illuminazione: la ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha, Roma, Donzelli, 1997;
- Yohaku: forme di ascesi nell’esperienza estetica orientale, Padova, Esedra, 2001;
- East & West. Identità e dialogo interculturale, Venezia, Marsilio, 2003;
- Il Buddhismo: i sentieri di una religione millenaria, Milano, Bruno Mondadori, 2003;
- Figure di pensiero. Opere e simboli nelle culture d’Oriente, Venezia, Marsilio, 2007;
- Oltre la filosofia, percorsi di saggezza tra oriente e occidente, Vicenza, Colla, 2008;
- Dieci lezioni sul buddhismo, Venezia, Marsilio, 2008;
- Per una filosofia interculturale (a cura di), Milano, Mimesis Edizioni, 2008;
- Taccuino giapponese, Udine, Forum, 2009;
- Tra Occidente ed Oriente: interviste sull’intercultura ed il pensiero orientale (a cura di Davide De Pretto), Milano, Mimesis Edizioni, 2010;
- Filosofia e globalizzazione, Milano, Mimesis Edizioni, 2011;
- Alfabeto filosofico, Venezia, Marsilio Edizioni, 2018;
- La via buddhista della meditazione, Quaderni di Meditazione n. 7, Corriere della Sera, Milano, RCS, 2020.