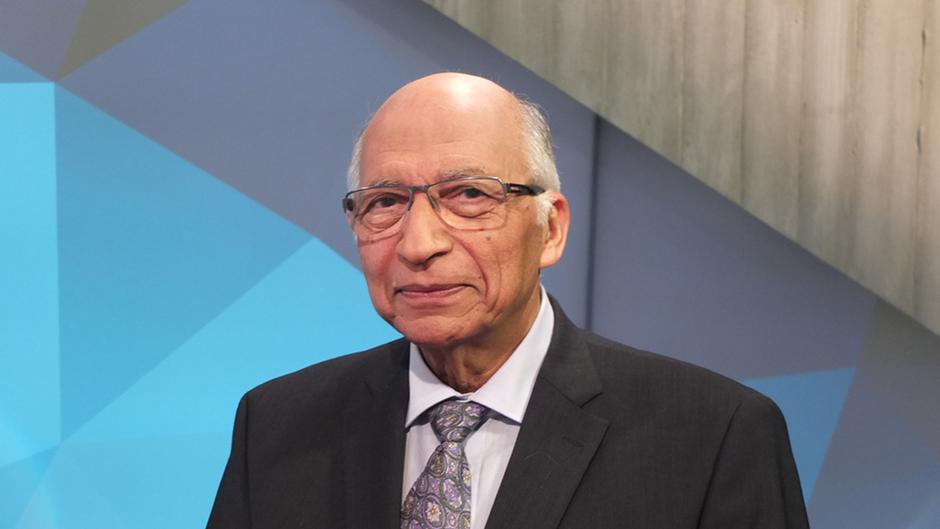Daisaku Ikeda (1928-2023) è stato un filosofo buddista, costruttore di pace, educatore nonché scrittore e poeta. Come terzo presidente della Soka Gakkai e poi della Soka Gakkai Internazionale si è dedicato alla diffusione della pace e dell’empowerment individuale su scala globale basandosi sugli insegnamenti del Buddismo di Nichiren Daishonin maestro buddista vissuto in Giappone nel tredicesimo secolo.

Nato a Tokyo Ikeda sperimentò in prima persona la tragica realtà del militarismo e della guerra. Queste esperienze formarono il giovane Ikeda, indirizzando fin dall’inizio il suo impegno verso la pace. Alla fine del conflitto mondiale, nel caos in cui era caduto il Giappone, giunse ad abbracciare il Buddismo in seguito all’incontro con Josei Toda, insegnante e pacifista e fondatore insieme a Makiguchi dell’organizzazione buddista laica Soka Gakkai.
Centrale nel suo pensiero è che la chiave per una pace duratura e la felicità degli esseri umani risiede nella trasformazione della vita di ciascun individuo più che nella sola riforma della società. Questo concetto è stato espresso nella frase di apertura del suo famoso romanzo La rivoluzione umana, per cui «la rivoluzione umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel destino di una nazione e condurrà infine a un cambiamento nel destino di tutta l’umanità».
Nel corso degli anni, mirando alla costruzione di una profonda comprensione tra tutti i popoli, cercando soluzioni ai problemi dell’umanità e per promuovere la sua visione sul dialogo e la solidarietà per la pace, Ikeda ha incontrato e dialogato con molti degli eminenti pensatori, accademici e “costruttori di pace” del nostro tempo, ha sostenuto attraverso la SGI le attività delle Nazioni Unite, scritto sui temi della pace e della condizione umana e fondato una serie di istituti di ricerca indipendenti e senza scopo di lucro che sviluppano una collaborazione interculturale e interdisciplinare su diverse questioni. Tra questi l’Associazione concertistica Min-on (1963) e il Fuji Art Museum di Tokyo (1983) che promuovono la comprensione reciproca e l’amicizia tra le diverse culture nazionali attraverso le arti.
Inoltre ha costituito l’Istituto di Filosofia Orientale (1962) per lo studio accademico del Buddismo e delle altre religioni, il Centro Ikeda per la Pace, l’Educazione e il Dialogo (1993) per la promozione del dialogo verso la pace e l’educazione alla cittadinanza globale, l’Istituto Toda per la Pace Globale (1996) allo scopo di agevolare la ricerca sulla sicurezza umana e il Sistema educativo Soka sistema scolastico laico basato sull’ideale della promozione del potenziale creativo unico di ogni studente e nel coltivare un’etica di pace e di coscienza globale. Il sistema scolastico va dalla scuola materna fino agli studi universitari in Giappone e una università negli Stati Uniti.
Gli scritti di Ikeda, che offrono punti di vista basati sull’umanesimo buddista per affrontare le sfide sia della vita quotidiana individuale sia dell’umanità nel suo insieme, sono stati tradotti in più di trenta lingue.
Dal 1983, il 26 gennaio di ogni anno – in commemorazione del giorno della fondazione della Soka Gakkai Internazionale – Daisaku Ikeda invia una “Proposta di Pace” alle Nazioni Unite e a personalità di tutto il mondo.
Al centro del suo pensiero si trovano riflessioni sulla pace, sulla convivenza degli esseri umani nel pianeta, sul rispetto per l’ambiente e per ogni forma di vita, sull’abolizione delle armi nucleari, della guerra e della violenza, sul rafforzamento delle Nazioni Unite. Ikeda pone una particolare attenzione ai processi educativi: strumenti fondamentali per la formazione di cittadini che sentano il mondo intero come loro casa e siano preparati per quella che Ikeda definisce “la diplomazia della gente comune”. Gli scritti prendono in esame tutti i problemi che l’umanità si trova ad affrontare e mettono in risalto – oltre alle possibili soluzioni – anche le basi filosofiche che possono sostenere e promuovere un radicale cambiamento.- Anno 2022 – Trasformare la storia umana: la luce della pace e della dignità

- Anno 2021 – La creazione di valore in tempi di crisi

- Anno 2020 – Verso un futuro comune: costruire un’epoca di solidarietà umana

- Anno 2019 – Verso una nuova era di pace e disarmo: un approccio centrato sulle persone

- Anno 2018 – Un movimento di persone comuni verso l’era dei diritti umani

- Anno 2017 – La solidarietà globale dei giovani annuncia un’era di speranza

- Anno 2016 – Il rispetto universale della dignità umana: la grande strada che porta alla pace

- Anno 2015 – Un impegno condiviso per un futuro più umano. Eliminare l’infelicità dalla terra

- Anno 2014 – Creazione di valore per un cambiamento globale. Costruire società resilienti e sostenibili

- Anno 2013 – Compassione, coraggio e speranza:costruire una società globale di pace e coesistenza creativa

- Anno 2012 – Sicurezza umana e sostenibilità, condividere un profondo rispetto per la dignità della vita

- Anno 2011 – Verso un secolo di dignità per tutti: il trionfo della vita creativa

- Anno 2010 – Verso una nuova era di creazione di valore

- Anno 2009 – Verso la competizione umanitaria: una nuova corrente nella storia

- Anno 2008 – Umanizzare la religione per creare la pace

- Anno 2007 – Ristabilire le connessioni umane: il primo passo verso la pace mondiale

- Anno 2006 – Verso l’epoca di un nuovo popolo. Il grande cammino della pace

- Anno 2005 – Verso una nuova era di dialogo: esplorare l’umanesimo

- Anno 2004 – Trasformazione interiore: il movimento profondo che crea un’onda globale di pace

- Anno 2003 – Un’etica di coesistenza globale

- Anno 2002 – L’umanesimo della via di mezzo

- Anno 2001 – Creare e sostenere un ecolo di vita: le sfide di una nuova era

- Anno 2000 – Pace attraverso il dialogo. Riflessioni su una cultura di pace

- Anno 1999 – Verso una cultura di pace. Una visione cosmica

- Anno 1998 – L’umanità e il nuovo millennio: dal caos al cosmo

- Anno 1997 – Nuovi orizzonti di una civiltà globale

- Anno 1996 – Verso il terzo millennio: la sfida dei cittadini del mondo

- Anno 1995 – Verso un secolo di pace e solidarietà

- Anno 1994 – Una nuova alba nella storia dell’umanità

- Anno 1993 – Verso un mondo più umano nel prossimo secolo

- Anno 1992 – Un rinascimento di speranza e di umanità

- Anno 1991 – L’alba del secolo dell’umanità

- Anno 1990 – Verso un nuovo secolo di speranza: il trionfo della democrazia

- Anno 1989 – Una nuova globalizzazione

- Anno 1988 – Cultura e disarmo: i fondamenti della pace nel mondo

- Anno 1987 – Diffondere lo splendore della pace verso il secolo dell’umanità

- Anno 1986 – Un movimento globale per una pace duratura

- Anno 1985 – Nuove onde di pace per il XXI secolo

- Anno 1984 – Costituzione di un movimento unitario per un mondo senza guerre

- Anno 1983 – Una nuova proposta per la pace e il disarmo

Questo testo, presentato alla Conferenza mondiale sull’ambiente di Rio de Janeiro 2012 dal titolo “Il futuro che vogliamo“, è rivolto a tutti gli abitanti della Terra che, come vicini di casa, condividono questo pianeta e devono imparare a sviluppare una visione chiara di quale dovrebbe essere il rapporto ideale tra l’umanità e il globo terracqueo.
Questa indispensabile visione diventerà realtà solo se sarà percepita come un impegno individuale da un numero sempre maggiore di persone, riflessa nella vita quotidiana e riconosciuta come una linea guida per
impostare nuovi stili di vita. Ogni persona deve sentirsi autorizzata ad agire da protagonista per proteggere la dignità inalienabile della vita e il valore insostituibile di ciò che la circonda, generando onde di cambiamento nelle comunità e nella società intera. Senza questa presa di coscienza non si avrà mai una vera trasformazione.
Punti chiave
In questa proposta, il presidente della SGI Daisaku Ikeda offre suggerimenti precisi da sottoporre all’attenzione della Conferenza Rio+20, concentrandosi su tre macro-argomenti:
1. Cominciare a stabilire un insieme di obiettivi condivisi per un futuro sostenibile
Un nuovo insieme di obiettivi per uno sviluppo sostenibile – come emanazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio – dovrebbe fungere da catalizzatore per promuovere un cambiamento positivo nelle persone in
vista della costruzione di una società globale. Al centro di questi obiettivi deve esserci un impegno lungimirante teso al benessere dell’umanità intera e della comunità globale. Fra i concetti cardine ci sono la sicurezza umana, il potere morbido e l’economia verde. I nuovi obiettivi devono avere come luogo fulcro delle proprie azioni la comunità. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono riguardare anche le città, collegate da un sistema che ne potenzi la capacità di condividere il sapere tecnologico e le prassi migliori.
Alcuni esempi di impegno proattivo delle comunità locali possono essere:
• progetti di forestazione per tutelare l’ecologia locale
• sforzi incentrati sui singoli cittadini per creare comunità maggiormente resilienti di fronte ai disastri
• connessione con altre comunità per aumentare il livello di produttività e consumo locali
• rendere la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti parte integrante della vita di ogni persona
• favorire l’introduzione di energie rinnovabili.
2. Istituire una nuova organizzazione internazionale attraverso la fusione di agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di ambiente e sviluppo
Serve una “organizzazione globale per lo sviluppo sostenibile” che sia il prodotto di una trasformazione audace e qualitativa del sistema attuale, in sintonia con le seguenti linee:
• Consolidamento delle sezioni e agenzie pertinenti, fra cui l’UNDP e l’UNEP
Dobbiamo sviluppare la capacità istituzionale di gettare le fondamenta per una vita dignitosa e di attuare risposte esaustive che diano priorità ai bisogni reali e manifesti delle persone.
• Partecipazione alle delibere della nuova organizzazione da parte di tutti i governi interessati
Attualmente, sia l’UNDP, sia l’UNEP sono strutturati in modo che solo gli stati membri dei rispettivi consigli direttivi possono esprimere decisioni vincolanti. Data l’importanza dello sviluppo sostenibile e la vastità delle questioni e dei settori coinvolti, dobbiamo garantire la piena partecipazione a tutti gli stati che lo desiderino.
• Piena collaborazione con la società civile
La Conferenza Rio+20 deve rappresentare l’occasione per sancire la collaborazione fra le Nazioni Unite e l’intero ventaglio di attori della società civile, fra cui ONG, istituti accademici, di ricerca e di affari che sono il centro di qualunque ristrutturazione istituzionale.
• Partecipazione attiva e coinvolgimento dei giovani
Bisogna costituire un “comitato delle generazioni future” come forum in cui i rappresentanti dei giovani di tutto il mondo possano valutare percorsi per un futuro sostenibile e consigliare la nuova organizzazione sostenibile sui piani e le politiche annuali.
3. Raccomandare all’Assemblea Generale dell’ONU la creazione di un ulteriore contesto educativo che favorisca la sostenibilità
Un “programma educativo per una società globale sostenibile” a partire dal 2015 deve inserirsi nel solco del Decennio dell’educazione a uno sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (2005-2014). Nel contesto successivo al Decennio si deve puntare a coltivare le capacità di un gran numero di persone che possono essere i veri portatori di cambiamento, tramite la diffusione di un’ondata trasformativa nelle comunità e nelle società. Le qualità di un’educazione basata sulla comunità in un quadro istituzionale successivo al decennio dovrebbero comprendere:
• Non limitarsi a fornire semplicemente la conoscenza dell’ambiente naturale, delle usanze e della storia della comunità locale, ma stimolare la determinazione a valorizzarli.
• Ispirare un profondo apprezzamento per i modi in cui l’ambiente circostante, comprese le attività produttive ed economiche degli altri abitanti della comunità, migliora la nostra vita, con la finalità di incoraggiare azioni basate su tale apprezzamento.
• Mettere in grado le persone di considerare i problemi della comunità locale come qualcosa che va tutelato per il bene delle generazioni future e per il tipo di società che vogliamo costruire.
Lo scopo finale è mettere le persone in grado di passare dall’empowerment all’assunzione di un ruolo di primo piano all’interno delle proprie comunità, e incoraggiare gli individui a essere protagonisti e a valorizzare l’inalienabile dignità di ogni persona e l’insostituibile valore di tutto ciò che ci circonda.
In tutte queste proposte l’attenzione è centrata sul tipo di empowerment che fa emergere il potenziale davvero illimitato che ciascuno di noi possiede. Le risorse materiali sono limitate, ma il potenziale umano è infinito, così come la nostra capacità di creare valore. Il vero significato della sostenibilità sta nel concetto dinamico della costante ricerca o competizione per creare valore positivo e condividerlo con il mondo e con l’avvenire.
È fondamentale essere solidi – per trovare un punto di riferimento da cui percepire l’impatto delle proprie azioni e sentire che stiamo facendo progressi concreti nel trasformare la realtà.
Questo è il ruolo della comunità locale. Se non siamo in grado di incidere nell’ambito delle nostre relazioni e dell’ambiente più prossimi, non possiamo sperare di fare la differenza per il pianeta o per il lontano futuro. Non dobbiamo considerare la ricerca della sostenibilità semplicemente come una questione di adeguamento delle politiche allo scopo di ottenere un migliore equilibrio fra imperativi economici ed ecologici.
Piuttosto, la sostenibilità va intesa come una sfida e un’impresa che richiede l’impegno di ogni individuo. In senso profondo, la sostenibilità è il lavoro di costruire una società che assegna la priorità più alta alla dignità della vita.
Puoi leggere il testo integrale da qui
Costruire una solidarietà globale per l’abolizione del nucleare
Se le armi nucleari sono la massima rappresentazione delle forze in grado di dividere e distruggere il mondo, esse possono essere neutralizzate solo dalla solidarietà dei cittadini comuni, che ha il potere di fare della speranza una forza irresistibile che trasforma la storia.
Albert Einstein (1879-1955), uno dei più grandi fisici del ventesimo secolo, riteneva di aver compiuto il più grave errore della sua vita il giorno in cui aveva scritto al presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt (1882-1945) informandolo del rischio che i nazisti sviluppassero un’arma atomica e sollecitandolo a rispondere rapidamente a quella minaccia.
Nel 1929 Einstein aveva dichiarato: «Rifiuterei con decisione qualunque incarico legato direttamente o indirettamente alla guerra […] a prescindere dalle ragioni a supporto della guerra». Tuttavia i suoi sentimenti pacifisti furono travolti dal peso della logica militare. Se le armi nucleari sono la massima rappresentazione delle forze in grado di dividere e distruggere il mondo, esse possono essere neutralizzate solo dalla solidarietà dei cittadini comuni, che ha il potere di fare della speranza una forza irresistibile che trasforma la storia.
Ciò che alla fine, circa dieci anni dopo, lo convinse a scrivere a Roosevelt – dietro consiglio di un suo collega scienziato – fu una profonda sensazione di paura e di ansia per le conseguenze che il mondo avrebbe dovuto subire nel caso che un’arma atomica fosse caduta nelle mani dei nazisti. Comprendeva più di chiunque altro la potenziale capacità distruttiva delle armi nucleari, e un simile esito era per lui impensabile.
I fattori che in origine avevano spinto Einstein a scrivere quella lettera divennero irrilevanti quando la sconfitta della Germania nazista tolse agli alleati la motivazione per lo sviluppo delle armi atomiche. Ma il sollievo di Einstein fu di breve durata, perché le bombe atomiche furono presto usate contro le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.
Sconvolto e turbato, nell’ultima decade della sua vita Einstein continuò a sollecitare la comunità internazionale affinché abolisse le armi nucleari. Nel 1947 in un articolo sull’Atlantic Monthly scrisse: «Dopo la preparazione della prima bomba atomica non si è compiuto niente per rendere il mondo più sicuro rispetto alla guerra, mentre molto è stato fatto per incrementare la capacità distruttiva della guerra». Questo articolo fu scritto un anno dopo il fallimento, alle Nazioni Unite, dei negoziati per il Piano Baruch – una proposta per il controllo internazionale dell’energia atomica – e l’inaugurazione dei programmi di sviluppo delle armi nucleari di Gran Bretagna e Unione Sovietica. Tre volte nel suo articolo Einstein ripeté il suo esasperato avvertimento.
Per quanto riguarda me, il 1947 fu l’anno in cui incontrai il mio maestro di vita, il secondo presidente della Soka Gakkai Josei Toda (1900-58). Arrestato per la sua resistenza al governo militarista giapponese durante la seconda guerra mondiale, Toda rimase fedele alle sue idee durante i due anni di prigionia, da cui riemerse dopo la guerra per mettersi alla testa di un movimento popolare per la pace.
Già nel 1949 avvertiva: «Se ci dovesse essere una guerra atomica, le popolazioni mondiali avrebbero un solo destino davanti a loro: quello della distruzione totale». Fece questa previsione subito dopo che l’Unione Sovietica aveva annunciato di aver collaudato la sua prima arma nucleare, seguendo l’esempio degli Stati Uniti.
Sono passati sessant’anni da quando il mondo è entrato nell’era della contrapposizione nucleare, ma non è stata ancora presa alcuna misura fondamentale in risposta all’avvertimento di Einstein. Al contrario, la situazione sta diventando sempre più pericolosa.
Anche se dalla fine della guerra fredda la minaccia di una guerra nucleare globale è diminuita, il numero di stati che possiedono armamenti nucleari è quasi raddoppiato dall’entrata in vigore, nel 1970, del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty). Nel mondo esistono ancora circa venticinquemila testate nucleari, e nello stesso tempo cresce il timore che la diffusione sul mercato nero dei materiali fissili e delle tecnologie per la produzione di tali ordigni possa scatenare l’incubo del terrorismo nucleare.
Nel discorso pronunciato a Praga nell’aprile di quest’anno (2009, n.d.r.), il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha sottolineato la responsabilità morale che hanno gli Stati Uniti per essere stati l’unico paese ad aver concretamente usato un’arma nucleare, e ha espresso la sua determinazione a rendere possibile un mondo senza armi nucleari.
Il presidente Obama si è incontrato con il presidente russo Dmitrij Medvedev in aprile e poi in luglio: in tali occasioni i capi di stato hanno concordato le linee generali di un trattato sul disarmo nucleare che sostituisca il Trattato di riduzione delle armi strategiche (START I, Strategic Arms Reduction Treaty), in scadenza a dicembre.
Al vertice del G8 a l’Aquila è stata rilasciata una dichiarazione congiunta che esprime l’impegno a «creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari». Nel frattempo è stata fissata per il 24 settembre, nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una riunione speciale del Consiglio di Sicurezza sulla non-proliferazione e il disarmo nucleare. Questi sviluppi dimostrano che si sta avanzando verso una nuova direzione, verso nuove iniziative in grado di sbloccare l’attuale situazione di stallo.
In conclusione, questi propositi riusciranno a creare nuove correnti davvero capaci di trasformare quest’epoca? La Conferenza di revisione quinquennale delle parti coinvolte nel Trattato di non proliferazione nucleare, fissata per maggio 2010, sarà fondamentale.
L’ultima Conferenza di revisione, svoltasi nel 2005, non ha prodotto risultati significativi, impantanata nel contrasto tra gli stati che sostenevano la necessità di dare la precedenza al disarmo e quelli che consideravano prioritaria la non-proliferazione. Oggi alcuni segnali di compromesso, come la decisione di avviare i negoziati per un Trattato che proibisca la produzione di materiale fissile (FMCT, Fissile Material Cut-Off Treaty), presa quest’anno alla Conferenza sul disarmo (CD, Conference on Disarmament) a Ginevra, testimoniano il tentativo di evitare il ripetersi di tale fallimento. Questo cambiamento di clima, seppur apprezzabile, in sé non è sufficiente a dissipare le nubi nere dell’era nucleare. Dobbiamo affrontare la questione fondamentale, al di là di interessi politici o militari: fino a che punto l’esistenza delle armi nucleari destabilizza il mondo e minaccia l’umanità.
Ora vorrei porre l’attenzione sulle parole dello storico britannico Arnold J. Toynbee (1889-1975). Nella sua opera A Study of History egli definisce la questione delle armi nucleari come «una sfida che non possiamo eludere», sollecitando tutte le persone a reagire.
Tra il 1972 e il 1973, Toynbee e io ci incontrammo per portare avanti un dialogo che in seguito venne pubblicato in inglese con il titolo Choose Life. Rimasi profondamente colpito da una sua osservazione: egli dichiarò che i governi del mondo dovevano adottare un «veto autoimposto» riguardo al possesso di armi nucleari.
In un’altra opera Toynbee descrisse l’impresa di reagire a tale sfida in questo modo: «La resistenza emotiva a questo rivoluzionario cambiamento di abitudini ormai radicate e a questa dolorosa rinuncia a istituzioni familiari dovrà essere superata grazie a una auto-educazione; nell’era atomica non si possono introdurre cambiamenti con la forza. I nodi si devono sciogliere con dita pazienti e non con un taglio netto».
Finora l’umanità è riuscita a evitare la catastrofe della guerra nucleare su vasta scala. Oggi però siamo di fronte a una serie di elementi destabilizzanti e quindi vorrei invitare i capi di tutti gli stati in possesso di armamenti nucleari, o la cui sicurezza nazionale dipende dalle armi nucleari di altri stati, a porsi queste domande:
Le armi nucleari sono davvero necessarie? Perché dobbiamo mantenerle?
Cosa giustifica lo stoccaggio di armi nucleari da parte della nostra nazione, dato che ci opponiamo se a possederle sono altri stati?
L’umanità non ha davvero altra scelta che vivere sotto la minaccia delle armi nucleari?
Leggi il testo integrale dal seguente link Proposta per l’abolizione del nucleare – Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
«La chiave per iniziare una battaglia spirituale fruttuosa in nome degli ideali dell’umanesimo – afferma Daisaku Ikeda – è il dialogo: una sfida che è antica (e nuova) quanto l’umanità stessa. Una delle caratteristiche essenziali degli umani è quella di essere creature dialogiche; abbandonare il dialogo significa abbandonare la nostra umanità. Senza dialogo la società è come avvolta nel silenzio della tomba».
Partendo da queste premesse, fin dai primi anni settanta Ikeda ha iniziato una serie di incontri con statisti, studiosi, “costruttori di pace”, premi Nobel per la Pace, artisti di tutto il mondo per avviare un processo di pace globale attraverso il dialogo. Molti di questi incontri sono diventati libri, tradotti nelle principali lingue del mondo e fonte di ispirazione per tante persone che desiderano realizzare la pace partendo dalle loro comunità di vita.
Nelakanta Radhakrishnan, presidente della Gandhi Smriti ha scritto: «Per me è chiaro che Ikeda sta portando a compimento alcuni concetti che Gandhi non ha potuto realizzare compiutamente. Più approfondisco il lavoro e il messaggio che Ikeda offre alle persone, più sono convinto che egli rappresenta una reale speranza per l’umanità sofferente.
Nell’ultimo dialogo con Gorbaciov egli ha detto: “Dobbiamo creare una società fondata sul dialogo che rispetti le differenze e accetti le diversità”. Daisaku Ikeda è un esempio di riformatore sociale moderno che ha saputo utilizzare l’infinito potenziale di una religione per costruire relazioni di amicizia e legami culturali tra le nazioni di tutto il mondo.
Insieme alla moglie Kaneko e ai membri della Soka Gakkai internazionale Ikeda continua a percorrere la strada del dialogo per la costruzione di un nuovo umanesimo che trascenda derive settarie, dogmatiche e fondamentaliste».
Molti dei sui dialoghi sono diventati libri tradotti in numerose lingue.
Per un elenco aggiornato dei dialoghi pubblicati in italiano https://esperiashop.it/it/
In questa sezione vengono indicati alcuni saggi scritti da Ikeda e tradotti in italiano.
Riproponiamo i capitoli pubblicati sulla rivista Buddismo e Società del libro Per il bene della pace. Sette sentieri verso l’armonia globale: una prospettiva buddista.
- Prefazione
- 1° Una prospettiva di pace
- 2° La via del dominio di sé
- 3° La strada del dialogo e della tolleranza
- 4.1° La via della comunità
- 4.2° La via della comunità
- 5.1° La via della cultura
- 5.2° I padroni del linguaggio
- 6° Il sentiero delle nazioni
- 7° Il sentiero della consapevolezza
- 8° Il sentiero del disarmo
Altri titoli:
- La Saggezza del Sutra del Loto vol. 1,2,3. Tramite una serie di dialoghi che esaminano i profondi significati simbolici del Sutra del Loto, Ikeda offre un’interpretazione attuale e concreta di questo testo, che si rivela un insegnamento chiave per aprire nuove prospettive al genere umano all’alba del terzo millennio.Nel primo volume vengono presi in esame i capitoli che vanno dal primo (Introduzione) all’undicesimo (L’apparizione della Torre preziosa). Nel secondo volume affronta i temi presenti nei capitoli dal dodicesimo al sedicesimo. Tra questi la predizione dell’illuminazione per gli esseri malvagie per le donne, mai considerata possibile nei sutra precedenti. Nel terzo volume affronta i capitoli dal diciassettesimo al ventottesimo. Particolare risalto assumono la figura del Bodhisattva Mai Sprezzante, che rappresenta il modello ideale del discepolo del Budda dedito a diffonderne la parola, e la cerimonia di affidamento, con la quale il Budda conferisce a tutti i discepoli la missione di propagare il suo insegnamento nelle epoche future.
- La vita mistero prezioso Daisaku Ikeda rifacendosi alle lezioni del Budda Shakyamuni intraprende l’esplorazione della natura e della forza vitale che muove il cosmo e gli individui, e le tre sezioni in cui si articola il libro sviscerano ogni aspetto del problema: l’apparente contrapposizione tra spirito e materia; le infinite possibilità dell’esistenza umana; infine l’ineluttabilità della morte e il suo valore in rapporto alla vita. Partendo dalle moderne soluzioni scientifiche e considerando le risposte cui sono giunte le filosofie occidentali e orientali, è negli insegnamenti del Budda che l’autore individua la più autentica indicazione circa la via che l’uomo contemporaneo deve intraprendere per conseguire la vera dignità dell’esistenza.
- I misteri di nascita e morte, la visione buddista della vita Il Buddismo di Nichiren, benché risalente a oltre settecento anni, fa propone una validissima ricetta per il senso d’impotenza e la disperazione che oggi pervadono la società. Il destino, ovviamente, non sempre si rivela in accordo con i nostri desideri, ma il Buddismo, e specialmente il Buddismo di Nichiren, ci consente di sviluppare il potere necessario per trasformarlo.
- Gioia nella vita e gioia nella morte, affrotare le quattro sofferenze Secondo gli insegnamenti del Buddismo gli esseri umani pososno assaporare la gia sia nella vita che nella morte se attingono alla particolare condizione vitale chiamata Buddità. Ikeda frronta le questioni fondamentali della via dialogando con alcuni medici e infermieri.
- La religione della rivoluzione umana In questo volume sono raccolte dodici lezioni della serie “Il Buddismo del sole”. Il Maestro Ikeda delinea il profilo di una religione autenticamente umanistica, capace di permettere a ogni persona di rivoluzionare la propria condizione vitale e di contribuire a un cambiamento positivo della società, influenzando il destino dell’intera umanità. Vengono affrontati princìpi cardine del Buddismo partendo dagli scritti del Daishonin.
- La vita del Budda Interpretazione della vita e delle scelte del Budda Shakyamuni.
- Buddismo il primo millennio Il volume affronta lo sviluppo del Buddismo dopo la morte del suo fondatore. A partire dal primo concilio, organizzato dai discepoli diretti di Shakyamuni, che mise ordine nel complesso sistema degli insegnamenti del Budda, fino alla nascita del movimento Mahayana, le cui origini restano poco definite. Daisaku Ikeda esamina le scarse notizie storiche giunte sino a noi ed espone i principi essenziali del Sutra del Loto e ripercorre le vicende di alcuni protagonisti della storia del Buddismo: il re Ashoka e i filosofi Nagarjuna e Vasubandhu, che contribuirono alla sua affermazione come una delle principali religioni mondiali.
- Buddismo in Cina Storia della diffusione del buddismo in Cina e cronaca dell’incontro tra due grandi civiltà asiatiche quella dell?India dove nacque l’insegnamento e quella della Cina dove il buddismo si trasformò in una religione universale e da cui gli insegnamenti vennero tramandati in Corea e Giappone.
L’educazione Soka Nel volume Daisaku Ikeda esamina il pensiero pedagogico di Tsunesaburo Makiguchi, pioniere dell’educazione creativa, e sviluppa il tema della formazione di una coscienza globale nei giovani e il dialogo e lo scambio come preziose opportunità di arricchimento per ogni persona.
Questa sezione è dedicata ai testi delle conferenze che Daisaku Ikeda ha tenuto dal 1975 al 1995 presso università, istituti di ricerca e accademie in tutto il mondo (raccolti nel volume Un Nuovo Umanesimo edito dalla casa editrice Esperia, 2004, Milano).
I testi di queste conferenze mirano alla creazione di una società che valorizzi l’individuo e le sue infinite potenzialità nel mondo di fine millennio, alla ricerca di nuovi equilibri.
Daisaku Ikeda cerca di creare legami, ponti di amicizia e comprensione nello sforzo costante di superare la diffidenza che divide l’Occidente dall’Oriente, una nazione dall’altra esplorando il patrimonio lasciato in eredità al genere umano dai grandi pensatori.
Prendendo a prestito le parole di personaggi del calibro di Tolstoj, Gandhi, Leonardo da Vinci, Pascal o dei saggi dell’antica Cina, Ikeda coglie i punti in comune tra le diverse culture e esalta le caratteristiche peculiari di ogni popolo.
PARTE PRIMA: ARTE, LETTERATURA ED EDUCAZIONE
Accademia delle Belle Arti dell’Institut de France, Parigi, 14 giugno 1989
L’arte, come la religione, rappresenta il legame dell’individuo con la realtà fondamentale e il punto di partenza per la rinascita del genere umano. L’arte è un processo collegato all’essenza stessa della vita, intesa come tensione dinamica in cui si opera una profonda fusione tra l’“io” (il microcosmo) e “l’universo” (il macrocosmo). È da tale “realtà fondamentale” che l’essere umano attinge energia per il proprio rinnovamento: qui egli trova una ragione di essere e il cardine della propria ricerca. (…)
Università di Ankara, Turchia, 24 giugno 1992
Molto più di un semplice processo di occidentalizzazione, il kemalismo è il prodotto di una terra, la Turchia, che è punto di incontro tra Est e Ovest. L’apertura mentale e l’aspirazione all’universalismo sono le correnti che fluiscono nella profondità della struttura istituzionale di questo movimento. Il punto forte della rivoluzione kemalista è stato l’intervento educativo, strumento fondamentale per la creazione di una nuova Turchia (…)
Università di Pechino, 28 maggio 1990
L’educazione è la forza fondamentale che costruisce la società e forgia un’epoca, alimenta e forma l’infinito potenziale che alberga in ognuno di noi e dirige la nostra energia verso la creazione di valore (…)
Università delle Filippine, 10 aprile 1991
Il termine bayanihan, che significa “aiuto reciproco nella comunità”, esprime lo spirito tradizionale delle Filippine, uno spirito che dovrebbe diventare patrimonio di tutta l’umanità. Daisaku Ikeda porge le sue scuse – come cittadino giapponese – al popolo filippino per le atrocità commesse dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale (…)
Università di Bologna, 1° giugno 1994
La formazione di un nuovo e globale sistema imperniato sull’ONU dipende da quanti “cittadini del mondo”, in grado di sostenerlo, possano crescere e svilupparsi. Mai come in quest’epoca, immersa nei gravi problemi di fine secolo, l’umanità ha bisogno di un patrimonio spirituale come quello di Leonardo Da Vinci, genio cosmopolita del Rinascimento italiano, il cui sguardo universale sul mondo fu animato da un vero umanesimo cosmico (…)
Università M.V. Lomonosov, Mosca, 17 maggio 1994
Occorre che l’essere umano sia posto al centro di tutto, e che le persone diventino indipendenti spiritualmente, risvegliandosi alla realtà fondamentale della vita. Allo stesso tempo, è necessario allargare la nostra vita per comprendere l’universo, per rivitalizzare e coltivare il nostro dinamismo interiore (…)
PARTE SECONDA: DIMENSIONI DELLA CULTURA
Università M. V. Lomonosov, Mosca, 27 maggio 1975
La letteratura russa si è sviluppata all’unisono con il desiderio di felicità, libertà e pace delle persone comuni; non sarebbe potuta nascere separata dal popolo e senza una profonda comprensione della natura umana. In tempi come quelli attuali, in cui urge l’unità a livello mondiale, questo spirito della cultura russa deve diventare una forza ispiratrice per tutti i popoli, e contribuire alla qualità degli scambi culturali nel XXI secolo, nella costruzione di una Via della Seta spirituale che unisca i cuori dei popoli di Oriente e Occidente (…)
Università di Guadalajara, Messico, 5 marzo 1981
Lo spirito poetico, il sorriso, l’empatia sono indispensabili per stabilire buone relazioni umane e realizzare la pace. L’anima del popolo messicano, mai vinto in tre secoli di oppressione coloniale, si è fortificata nell’esperienza della rivoluzione e può quindi offrire un grande contributo alla pace. Il Buddismo spiega il legame profondo che unisce tutti gli esseri viventi tra loro e con il loro ambiente. È tempo che tutte le nazioni e i popoli riconoscano e valorizzino questo legame (…)
Università Saint Kliment Ohridsky, Sofia, Bulgaria, 21 maggio 1981
Il futuro dello spirito nazionale della Bulgaria dipende dalla saggezza dei suoi cittadini. Le barriere che separano le nazioni saranno sicuramente superate, aprendo la via verso una umanistica società globale del XXI secolo. Il leone, simbolo della Bulgaria, ha un significato profondo anche nel Buddismo: il re Ashoka fece erigere una stele con quattro leoni nel luogo dove il Budda aveva esposto per la prima volta il Dharma. Il leone è il simbolo dell’insegnamento del Budda che arriva al cuore della gente (…)
Università Bucarest, Romania, 7 giugno 1983
Dietro il concetto di stato nazionale si cela una cultura umana infinitamente varia, fondata su migliaia di anni di storia e tradizioni. Per realizzare l’ideale di un mondo unificato è importante riconoscere valori spirituali universali che leghino fra loro le tradizioni culturali a livello locale e permettano allo stesso tempo a ciascuna di brillare di luce propria. Mircea Eliade, uno dei più grandi filosofi della religione di questo secolo, nato in Romania, nutriva la speranza che l’incontro tra le popolazioni dell’Occidente moderno con il mondo non occidentale facesse emergere un nuovo umanesimo (…)
Università di Macao, Cina, 30 gennaio 1991
Tremila anni di storia della Cina sono permeati dal senso di armonia, una «innata consapevolezza» e sensibilità che portano allo spirito umano ordine e prospettiva cosmopolita. Questa spiritualità, unica nel suo genere, è evidente sia nel Buddismo cinese sia in quello mahayana giapponese. Anche le cinque virtù cardinali della filosofia confuciana – gentilezza, rettitudine, decoro, giudizio e lealtà –, se interpretate alla luce di questa grande tradizione cinese, si rivitalizzano e assumono un nuovo significato come linee guida per il XXI secolo (…)
Università Fudan, Shangai, Cina, 9 giugno 1984
Pochi sono i paesi che possono eguagliare la Cina nella profondità del suo interesse per la storia, tradizionalmente considerata il nutrimento che alimenta la vita e gli esseri umani perché sostiene la creazione di un presente e un futuro migliori. Se la storia è utilizzata per scrutare il destino degli esseri umani, la cronaca degli eventi passati non può rimanere indipendente da loro ma ne deve essere coinvolta. Oggi, per quanto gli eventi possano essere imprevedibili, dobbiamo imparare a considerare la storia come un dramma in cui le persone ricoprono un ruolo decisivo e sviluppare una solidarietà degna di cittadini di uno stesso mondo (…)
PARTE TERZA: LA RELIGIONE E IL NOSTRO TEMPO
Università di Pechino, 22 aprile 1980
Nessuna idea nella cultura cinese può essere ricondotta a un concetto giudaico-cristiano o islamico di Dio. La sua visione degli esseri umani e del mondo è «una visione dell’universale alla luce del particolare»: in base a questa tendenza i cinesi non hanno fatto ricorso a mediazioni come il monoteismo, ma sono riusciti a desumere direttamente dalla realtà profondi principi di validità universale. Uno degli elementi più raffinati dell’eredità spirituale della Cina è la convinzione che un individuo si debba confrontare direttamente con la realtà e, su questa base, decidere come meglio ricostruirla (…)
California University, Los Angeles, 1° aprile 1974
In ogni essere umano c’è un “piccolo io” e un “sé eterno e universale”. Cadere in preda ai desideri ed essere incapace di controllarli significa vivere per soddisfare il “piccolo io”. Vivere per il “sé eterno” vuol dire conoscere il principio universale che sottende ogni cosa e risvegliarsi a ciò che esiste al di là dei fenomeni transitori. Il “sé eterno” è il principio fondamentale che regola tutto l’universo (…)
Museo Nazionale dell’India, Nuova Delhi, 11 febbraio 1992
Gandhi credeva nell’immenso potere spirituale e religioso di ognuno di noi. Credeva inoltre che questa profonda sorgente di energia e di forza non dovesse rimanere assopita, ma essere risvegliata e utilizzata. Non riconoscendo “altro Dio che la Verità” e restando fermo nel suo rifiuto del settarismo, Gandhi manifestava una grande forza spirituale. Questa stessa spiritualità guarirà e rivitalizzerà i cuori e le menti degli esseri umani feriti dalle ideologie violente del nostro tempo (…)
Accademia cinese delle Scienze Sociali, Pechino, 14 ottobre 1992
Nel XXI secolo il mondo dovrà prestare sempre più attenzione non solo alle capacità economiche dell’Est asiatico, ma soprattutto alla sua profonda tradizione spirituale. Questa regione del pianeta diventerà una forza guida nella storia, una sorgente di speranza per tutte le persone (…)
Harvard University, Cambridge, Usa, 24 settembre 1993
Al Buddismo mahayana spetta un ruolo importante nel cammino della civiltà umana verso il XXI secolo. Tre i punti chiave: la tradizionale propensione buddista alla nonviolenza e al dialogo, la ricerca di un equilibrio tra le forze individuali e tutto ciò che esiste al di là di esse e la relazione che unisce profondamente ogni individuo a tutte le altre forme di vita esistenti (…)
Claremont McKenna College, Usa, 29 gennaio 1993
Come il radicalismo è destinato per natura a ricorrere alla violenza e al terrore, così lo strumento più potente dell’approccio gradualista è il dialogo. L’armonia umana può essere sostenuta soltanto nell’ambito dello spazio aperto creato dal dialogo condotto con i nostri simili, con la storia, con la natura e l’universo, anche allo scopo di recuperare la totalità e l’unità dell’esperienza umana così disastrosamente erosa da un’accelerata frammentazione del sapere (…)
PARTE QUARTA: L’IMPERATIVO DELLA PACE
Università Shenzhen, Guangdong, Cina, 31 gennaio 1994
In quest’epoca di crepuscolo degli dei, sembra appropriato cercare «un concetto di moralità, un modello etico che non sia mai stato sostenuto da sanzioni da parte del sovrannaturale»; a questo riguardo la cultura cinese può offrire un inestimabile dono al mondo (Joseph Needham). La forza morale umanista che la Cina ha accumulato lungo la sua storia, il suo spirito fondato sulla fiducia in sé, sull’autodisciplina e sul personale miglioramento sono forse destinati a dare pace non solo alla metà, ma al mondo intero (Arnold Toynbee) (…)
Accademia delle Lettere del Brasile, Rio de Janeiro, 12 febbraio 1993
Il Brasile, democrazia caratterizzata da diversità etnica, è un prezioso esempio per il futuro e un antidoto per eventi che tendono alla divisione. Il temperamento dei brasiliani, contraddistinto da apertura mentale, gentilezza, ospitalità e generosità di spirito, trae la propria origine spirituale dal senso di universalità e disponibilità verso la vita e l’universo. Ma i frutti del grande universalismo di questo paese potranno essere raccolti soltanto quando ci sarà quella tensione tra universalismo e particolarismo verso cui il Buddismo mahayana ci orienta (…)
Università di Buenos Aires, Argentina, 1° marzo 1990
Oggi si sta delineando una grande transizione e non è più possibile per nessuno stato o regime perseverare in una politica di isolazionismo. La principale sfida che affrontiamo all’alba del XXI secolo è di cambiare marcia e trovare un modo per armonizzare il nazionalismo con il globalismo. L’Argentina presenta delle straordinarie diversità geografiche ed etniche. L’emersione dell’individuo cosmopolita rappresenta quel genere di trasformazione necessaria per il futuro: ecco perché considero l’Argentina lo stato precursore del nuovo globalismo (…)
John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Usa, 26 settembre 1991
Le energie generate nell’essere umano dall’impulso di creare benessere per l’umanità possono diventare le basi per un nuovo tipo di potere: quello che si fonda sul dialogo, sul rispetto per la vita e sull’autocontrollo. Un “potere morbido” da contrapporre al “duro” prevalere della guerra e della violenza (…)
Daisaku Ikeda (1928-2023) è stato un filosofo buddista, costruttore di pace, educatore nonché scrittore e poeta. Come terzo presidente della Soka Gakkai e poi della Soka Gakkai Internazionale si è dedicato alla diffusione della pace e dell’empowerment individuale su scala globale basandosi sugli insegnamenti del Buddismo di Nichiren Daishonin maestro buddista vissuto in Giappone nel tredicesimo secolo.

Nato a Tokyo Ikeda sperimentò in prima persona la tragica realtà del militarismo e della guerra. Queste esperienze formarono il giovane Ikeda, indirizzando fin dall’inizio il suo impegno verso la pace. Alla fine del conflitto mondiale, nel caos in cui era caduto il Giappone, giunse ad abbracciare il Buddismo in seguito all’incontro con Josei Toda, insegnante e pacifista e fondatore insieme a Makiguchi dell’organizzazione buddista laica Soka Gakkai.
Centrale nel suo pensiero è che la chiave per una pace duratura e la felicità degli esseri umani risiede nella trasformazione della vita di ciascun individuo più che nella sola riforma della società. Questo concetto è stato espresso nella frase di apertura del suo famoso romanzo La rivoluzione umana, per cui «la rivoluzione umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel destino di una nazione e condurrà infine a un cambiamento nel destino di tutta l’umanità».
Nel corso degli anni, mirando alla costruzione di una profonda comprensione tra tutti i popoli, cercando soluzioni ai problemi dell’umanità e per promuovere la sua visione sul dialogo e la solidarietà per la pace, Ikeda ha incontrato e dialogato con molti degli eminenti pensatori, accademici e “costruttori di pace” del nostro tempo, ha sostenuto attraverso la SGI le attività delle Nazioni Unite, scritto sui temi della pace e della condizione umana e fondato una serie di istituti di ricerca indipendenti e senza scopo di lucro che sviluppano una collaborazione interculturale e interdisciplinare su diverse questioni. Tra questi l’Associazione concertistica Min-on (1963) e il Fuji Art Museum di Tokyo (1983) che promuovono la comprensione reciproca e l’amicizia tra le diverse culture nazionali attraverso le arti.
Inoltre ha costituito l’Istituto di Filosofia Orientale (1962) per lo studio accademico del Buddismo e delle altre religioni, il Centro Ikeda per la Pace, l’Educazione e il Dialogo (1993) per la promozione del dialogo verso la pace e l’educazione alla cittadinanza globale, l’Istituto Toda per la Pace Globale (1996) allo scopo di agevolare la ricerca sulla sicurezza umana e il Sistema educativo Soka sistema scolastico laico basato sull’ideale della promozione del potenziale creativo unico di ogni studente e nel coltivare un’etica di pace e di coscienza globale. Il sistema scolastico va dalla scuola materna fino agli studi universitari in Giappone e una università negli Stati Uniti.
Gli scritti di Ikeda, che offrono punti di vista basati sull’umanesimo buddista per affrontare le sfide sia della vita quotidiana individuale sia dell’umanità nel suo insieme, sono stati tradotti in più di trenta lingue.
Dal 1983, il 26 gennaio di ogni anno – in commemorazione del giorno della fondazione della Soka Gakkai Internazionale – Daisaku Ikeda invia una “Proposta di Pace” alle Nazioni Unite e a personalità di tutto il mondo.
Al centro del suo pensiero si trovano riflessioni sulla pace, sulla convivenza degli esseri umani nel pianeta, sul rispetto per l’ambiente e per ogni forma di vita, sull’abolizione delle armi nucleari, della guerra e della violenza, sul rafforzamento delle Nazioni Unite.
Ikeda pone una particolare attenzione ai processi educativi: strumenti fondamentali per la formazione di cittadini che sentano il mondo intero come loro casa e siano preparati per quella che Ikeda definisce “la diplomazia della gente comune”.
Gli scritti prendono in esame tutti i problemi che l’umanità si trova ad affrontare e mettono in risalto – oltre alle possibili soluzioni – anche le basi filosofiche che possono sostenere e promuovere un radicale cambiamento.
- Anno 2022 – Trasformare la storia umana: la luce della pace e della dignità

- Anno 2021 – La creazione di valore in tempi di crisi

- Anno 2020 – Verso un futuro comune: costruire un’epoca di solidarietà umana

- Anno 2019 – Verso una nuova era di pace e disarmo: un approccio centrato sulle persone

- Anno 2018 – Un movimento di persone comuni verso l’era dei diritti umani

- Anno 2017 – La solidarietà globale dei giovani annuncia un’era di speranza

- Anno 2016 – Il rispetto universale della dignità umana: la grande strada che porta alla pace

- Anno 2015 – Un impegno condiviso per un futuro più umano. Eliminare l’infelicità dalla terra

- Anno 2014 – Creazione di valore per un cambiamento globale. Costruire società resilienti e sostenibili

- Anno 2013 – Compassione, coraggio e speranza:costruire una società globale di pace e coesistenza creativa

- Anno 2012 – Sicurezza umana e sostenibilità, condividere un profondo rispetto per la dignità della vita

- Anno 2011 – Verso un secolo di dignità per tutti: il trionfo della vita creativa

- Anno 2010 – Verso una nuova era di creazione di valore

- Anno 2009 – Verso la competizione umanitaria: una nuova corrente nella storia

- Anno 2008 – Umanizzare la religione per creare la pace

- Anno 2007 – Ristabilire le connessioni umane: il primo passo verso la pace mondiale

- Anno 2006 – Verso l’epoca di un nuovo popolo. Il grande cammino della pace

- Anno 2005 – Verso una nuova era di dialogo: esplorare l’umanesimo

- Anno 2004 – Trasformazione interiore: il movimento profondo che crea un’onda globale di pace

- Anno 2003 – Un’etica di coesistenza globale

- Anno 2002 – L’umanesimo della via di mezzo

- Anno 2001 – Creare e sostenere un ecolo di vita: le sfide di una nuova era

- Anno 2000 – Pace attraverso il dialogo. Riflessioni su una cultura di pace

- Anno 1999 – Verso una cultura di pace. Una visione cosmica

- Anno 1998 – L’umanità e il nuovo millennio: dal caos al cosmo

- Anno 1997 – Nuovi orizzonti di una civiltà globale

- Anno 1996 – Verso il terzo millennio: la sfida dei cittadini del mondo

- Anno 1995 – Verso un secolo di pace e solidarietà

- Anno 1994 – Una nuova alba nella storia dell’umanità

- Anno 1993 – Verso un mondo più umano nel prossimo secolo

- Anno 1992 – Un rinascimento di speranza e di umanità

- Anno 1991 – L’alba del secolo dell’umanità

- Anno 1990 – Verso un nuovo secolo di speranza: il trionfo della democrazia

- Anno 1989 – Una nuova globalizzazione

- Anno 1988 – Cultura e disarmo: i fondamenti della pace nel mondo

- Anno 1987 – Diffondere lo splendore della pace verso il secolo dell’umanità

- Anno 1986 – Un movimento globale per una pace duratura

- Anno 1985 – Nuove onde di pace per il XXI secolo

- Anno 1984 – Costituzione di un movimento unitario per un mondo senza guerre

- Anno 1983 – Una nuova proposta per la pace e il disarmo

Questo testo, presentato alla Conferenza mondiale sull’ambiente di Rio de Janeiro 2012 dal titolo “Il futuro che vogliamo“, è rivolto a tutti gli abitanti della Terra che, come vicini di casa, condividono questo pianeta e devono imparare a sviluppare una visione chiara di quale dovrebbe essere il rapporto ideale tra l’umanità e il globo terracqueo.
Questa indispensabile visione diventerà realtà solo se sarà percepita come un impegno individuale da un numero sempre maggiore di persone, riflessa nella vita quotidiana e riconosciuta come una linea guida per
impostare nuovi stili di vita. Ogni persona deve sentirsi autorizzata ad agire da protagonista per proteggere la dignità inalienabile della vita e il valore insostituibile di ciò che la circonda, generando onde di cambiamento nelle comunità e nella società intera. Senza questa presa di coscienza non si avrà mai una vera trasformazione.
Punti chiave
In questa proposta, il presidente della SGI Daisaku Ikeda offre suggerimenti precisi da sottoporre all’attenzione della Conferenza Rio+20, concentrandosi su tre macro-argomenti:
1. Cominciare a stabilire un insieme di obiettivi condivisi per un futuro sostenibile
Un nuovo insieme di obiettivi per uno sviluppo sostenibile – come emanazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio – dovrebbe fungere da catalizzatore per promuovere un cambiamento positivo nelle persone in
vista della costruzione di una società globale. Al centro di questi obiettivi deve esserci un impegno lungimirante teso al benessere dell’umanità intera e della comunità globale. Fra i concetti cardine ci sono la sicurezza umana, il potere morbido e l’economia verde. I nuovi obiettivi devono avere come luogo fulcro delle proprie azioni la comunità. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono riguardare anche le città, collegate da un sistema che ne potenzi la capacità di condividere il sapere tecnologico e le prassi migliori.
Alcuni esempi di impegno proattivo delle comunità locali possono essere:
• progetti di forestazione per tutelare l’ecologia locale
• sforzi incentrati sui singoli cittadini per creare comunità maggiormente resilienti di fronte ai disastri
• connessione con altre comunità per aumentare il livello di produttività e consumo locali
• rendere la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti parte integrante della vita di ogni persona
• favorire l’introduzione di energie rinnovabili.
2. Istituire una nuova organizzazione internazionale attraverso la fusione di agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di ambiente e sviluppo
Serve una “organizzazione globale per lo sviluppo sostenibile” che sia il prodotto di una trasformazione audace e qualitativa del sistema attuale, in sintonia con le seguenti linee:
• Consolidamento delle sezioni e agenzie pertinenti, fra cui l’UNDP e l’UNEP
Dobbiamo sviluppare la capacità istituzionale di gettare le fondamenta per una vita dignitosa e di attuare risposte esaustive che diano priorità ai bisogni reali e manifesti delle persone.
• Partecipazione alle delibere della nuova organizzazione da parte di tutti i governi interessati
Attualmente, sia l’UNDP, sia l’UNEP sono strutturati in modo che solo gli stati membri dei rispettivi consigli direttivi possono esprimere decisioni vincolanti. Data l’importanza dello sviluppo sostenibile e la vastità delle questioni e dei settori coinvolti, dobbiamo garantire la piena partecipazione a tutti gli stati che lo desiderino.
• Piena collaborazione con la società civile
La Conferenza Rio+20 deve rappresentare l’occasione per sancire la collaborazione fra le Nazioni Unite e l’intero ventaglio di attori della società civile, fra cui ONG, istituti accademici, di ricerca e di affari che sono il centro di qualunque ristrutturazione istituzionale.
• Partecipazione attiva e coinvolgimento dei giovani
Bisogna costituire un “comitato delle generazioni future” come forum in cui i rappresentanti dei giovani di tutto il mondo possano valutare percorsi per un futuro sostenibile e consigliare la nuova organizzazione sostenibile sui piani e le politiche annuali.
3. Raccomandare all’Assemblea Generale dell’ONU la creazione di un ulteriore contesto educativo che favorisca la sostenibilità
Un “programma educativo per una società globale sostenibile” a partire dal 2015 deve inserirsi nel solco del Decennio dell’educazione a uno sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (2005-2014). Nel contesto successivo al Decennio si deve puntare a coltivare le capacità di un gran numero di persone che possono essere i veri portatori di cambiamento, tramite la diffusione di un’ondata trasformativa nelle comunità e nelle società. Le qualità di un’educazione basata sulla comunità in un quadro istituzionale successivo al decennio dovrebbero comprendere:
• Non limitarsi a fornire semplicemente la conoscenza dell’ambiente naturale, delle usanze e della storia della comunità locale, ma stimolare la determinazione a valorizzarli.
• Ispirare un profondo apprezzamento per i modi in cui l’ambiente circostante, comprese le attività produttive ed economiche degli altri abitanti della comunità, migliora la nostra vita, con la finalità di incoraggiare azioni basate su tale apprezzamento.
• Mettere in grado le persone di considerare i problemi della comunità locale come qualcosa che va tutelato per il bene delle generazioni future e per il tipo di società che vogliamo costruire.
Lo scopo finale è mettere le persone in grado di passare dall’empowerment all’assunzione di un ruolo di primo piano all’interno delle proprie comunità, e incoraggiare gli individui a essere protagonisti e a valorizzare l’inalienabile dignità di ogni persona e l’insostituibile valore di tutto ciò che ci circonda.
In tutte queste proposte l’attenzione è centrata sul tipo di empowerment che fa emergere il potenziale davvero illimitato che ciascuno di noi possiede. Le risorse materiali sono limitate, ma il potenziale umano è infinito, così come la nostra capacità di creare valore. Il vero significato della sostenibilità sta nel concetto dinamico della costante ricerca o competizione per creare valore positivo e condividerlo con il mondo e con l’avvenire.
È fondamentale essere solidi – per trovare un punto di riferimento da cui percepire l’impatto delle proprie azioni e sentire che stiamo facendo progressi concreti nel trasformare la realtà.
Questo è il ruolo della comunità locale. Se non siamo in grado di incidere nell’ambito delle nostre relazioni e dell’ambiente più prossimi, non possiamo sperare di fare la differenza per il pianeta o per il lontano futuro. Non dobbiamo considerare la ricerca della sostenibilità semplicemente come una questione di adeguamento delle politiche allo scopo di ottenere un migliore equilibrio fra imperativi economici ed ecologici.
Piuttosto, la sostenibilità va intesa come una sfida e un’impresa che richiede l’impegno di ogni individuo. In senso profondo, la sostenibilità è il lavoro di costruire una società che assegna la priorità più alta alla dignità della vita.
Puoi leggere il testo integrale da qui
Costruire una solidarietà globale per l’abolizione del nucleare
Se le armi nucleari sono la massima rappresentazione delle forze in grado di dividere e distruggere il mondo, esse possono essere neutralizzate solo dalla solidarietà dei cittadini comuni, che ha il potere di fare della speranza una forza irresistibile che trasforma la storia.
Albert Einstein (1879-1955), uno dei più grandi fisici del ventesimo secolo, riteneva di aver compiuto il più grave errore della sua vita il giorno in cui aveva scritto al presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt (1882-1945) informandolo del rischio che i nazisti sviluppassero un’arma atomica e sollecitandolo a rispondere rapidamente a quella minaccia.
Nel 1929 Einstein aveva dichiarato: «Rifiuterei con decisione qualunque incarico legato direttamente o indirettamente alla guerra […] a prescindere dalle ragioni a supporto della guerra».1. Tuttavia i suoi sentimenti pacifisti furono travolti dal peso della logica militare. Se le armi nucleari sono la massima rappresentazione delle forze in grado di dividere e distruggere il mondo, esse possono essere neutralizzate solo dalla solidarietà dei cittadini comuni, che ha il potere di fare della speranza una forza irresistibile che trasforma la storia.
Ciò che alla fine, circa dieci anni dopo, lo convinse a scrivere a Roosevelt – dietro consiglio di un suo collega scienziato – fu una profonda sensazione di paura e di ansia per le conseguenze che il mondo avrebbe dovuto subire nel caso che un’arma atomica fosse caduta nelle mani dei nazisti. Comprendeva più di chiunque altro la potenziale capacità distruttiva delle armi nucleari, e un simile esito era per lui impensabile.
I fattori che in origine avevano spinto Einstein a scrivere quella lettera divennero irrilevanti quando la sconfitta della Germania nazista tolse agli alleati la motivazione per lo sviluppo delle armi atomiche. Ma il sollievo di Einstein fu di breve durata, perché le bombe atomiche furono presto usate contro le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.
Sconvolto e turbato, nell’ultima decade della sua vita Einstein continuò a sollecitare la comunità internazionale affinché abolisse le armi nucleari. Nel 1947 in un articolo sull’Atlantic Monthly scrisse: «Dopo la preparazione della prima bomba atomica non si è compiuto niente per rendere il mondo più sicuro rispetto alla guerra, mentre molto è stato fatto per incrementare la capacità distruttiva della guerra».2. Questo articolo fu scritto un anno dopo il fallimento, alle Nazioni Unite, dei negoziati per il Piano Baruch – una proposta per il controllo internazionale dell’energia atomica – e l’inaugurazione dei programmi di sviluppo delle armi nucleari di Gran Bretagna e Unione Sovietica. Tre volte nel suo articolo Einstein ripeté il suo esasperato avvertimento.
Per quanto riguarda me, il 1947 fu l’anno in cui incontrai il mio maestro di vita, il secondo presidente della Soka Gakkai Josei Toda (1900-58). Arrestato per la sua resistenza al governo militarista giapponese durante la seconda guerra mondiale, Toda rimase fedele alle sue idee durante i due anni di prigionia, da cui riemerse dopo la guerra per mettersi alla testa di un movimento popolare per la pace.
Già nel 1949 avvertiva: «Se ci dovesse essere una guerra atomica, le popolazioni mondiali avrebbero un solo destino davanti a loro: quello della distruzione totale».3. Fece questa previsione subito dopo che l’Unione Sovietica aveva annunciato di aver collaudato la sua prima arma nucleare, seguendo l’esempio degli Stati Uniti.
Sono passati sessant’anni da quando il mondo è entrato nell’era della contrapposizione nucleare, ma non è stata ancora presa alcuna misura fondamentale in risposta all’avvertimento di Einstein. Al contrario, la situazione sta diventando sempre più pericolosa.
Anche se dalla fine della guerra fredda la minaccia di una guerra nucleare globale è diminuita, il numero di stati che possiedono armamenti nucleari è quasi raddoppiato dall’entrata in vigore, nel 1970, del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty). Nel mondo esistono ancora circa venticinquemila testate nucleari, e nello stesso tempo cresce il timore che la diffusione sul mercato nero dei materiali fissili e delle tecnologie per la produzione di tali ordigni possa scatenare l’incubo del terrorismo nucleare.
Nel discorso pronunciato a Praga nell’aprile di quest’anno (2009, n.d.r.), il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha sottolineato la responsabilità morale che hanno gli Stati Uniti per essere stati l’unico paese ad aver concretamente usato un’arma nucleare, e ha espresso la sua determinazione a rendere possibile un mondo senza armi nucleari.
Il presidente Obama si è incontrato con il presidente russo Dmitrij Medvedev in aprile e poi in luglio: in tali occasioni i capi di stato hanno concordato le linee generali di un trattato sul disarmo nucleare che sostituisca il Trattato di riduzione delle armi strategiche (START I, Strategic Arms Reduction Treaty), in scadenza a dicembre.
Al vertice del G8 a l’Aquila è stata rilasciata una dichiarazione congiunta che esprime l’impegno a «creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari».4. Nel frattempo è stata fissata per il 24 settembre, nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una riunione speciale del Consiglio di Sicurezza sulla non-proliferazione e il disarmo nucleare. Questi sviluppi dimostrano che si sta avanzando verso una nuova direzione, verso nuove iniziative in grado di sbloccare l’attuale situazione di stallo.
In conclusione, questi propositi riusciranno a creare nuove correnti davvero capaci di trasformare quest’epoca? La Conferenza di revisione quinquennale delle parti coinvolte nel Trattato di non proliferazione nucleare, fissata per maggio 2010, sarà fondamentale.
L’ultima Conferenza di revisione, svoltasi nel 2005, non ha prodotto risultati significativi, impantanata nel contrasto tra gli stati che sostenevano la necessità di dare la precedenza al disarmo e quelli che consideravano prioritaria la non-proliferazione. Oggi alcuni segnali di compromesso, come la decisione di avviare i negoziati per un Trattato che proibisca la produzione di materiale fissile (FMCT, Fissile Material Cut-Off Treaty), presa quest’anno alla Conferenza sul disarmo (CD, Conference on Disarmament) a Ginevra, testimoniano il tentativo di evitare il ripetersi di tale fallimento. Questo cambiamento di clima, seppur apprezzabile, in sé non è sufficiente a dissipare le nubi nere dell’era nucleare. Dobbiamo affrontare la questione fondamentale, al di là di interessi politici o militari: fino a che punto l’esistenza delle armi nucleari destabilizza il mondo e minaccia l’umanità.
Ora vorrei porre l’attenzione sulle parole dello storico britannico Arnold J. Toynbee (1889-1975). Nella sua opera A Study of History egli definisce la questione delle armi nucleari come «una sfida che non possiamo eludere»,5. sollecitando tutte le persone a reagire.
Tra il 1972 e il 1973, Toynbee e io ci incontrammo per portare avanti un dialogo che in seguito venne pubblicato in inglese con il titolo Choose Life. Rimasi profondamente colpito da una sua osservazione: egli dichiarò che i governi del mondo dovevano adottare un «veto autoimposto» 6. riguardo al possesso di armi nucleari.
In un’altra opera Toynbee descrisse l’impresa di reagire a tale sfida in questo modo: «La resistenza emotiva a questo rivoluzionario cambiamento di abitudini ormai radicate e a questa dolorosa rinuncia a istituzioni familiari dovrà essere superata grazie a una auto-educazione; nell’era atomica non si possono introdurre cambiamenti con la forza. I nodi si devono sciogliere con dita pazienti e non con un taglio netto».7.
Finora l’umanità è riuscita a evitare la catastrofe della guerra nucleare su vasta scala. Oggi però siamo di fronte a una serie di elementi destabilizzanti e quindi vorrei invitare i capi di tutti gli stati in possesso di armamenti nucleari, o la cui sicurezza nazionale dipende dalle armi nucleari di altri stati, a porsi queste domande:
Le armi nucleari sono davvero necessarie? Perché dobbiamo mantenerle?
Cosa giustifica lo stoccaggio di armi nucleari da parte della nostra nazione, dato che ci opponiamo se a possederle sono altri stati?
L’umanità non ha davvero altra scelta che vivere sotto la minaccia delle armi nucleari?
Leggi il testo integrale dal seguente link Proposta per l’abolizione del nucleare – Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
«La chiave per iniziare una battaglia spirituale fruttuosa in nome degli ideali dell’umanesimo – afferma Daisaku Ikeda – è il dialogo: una sfida che è antica (e nuova) quanto l’umanità stessa. Una delle caratteristiche essenziali degli umani è quella di essere creature dialogiche; abbandonare il dialogo significa abbandonare la nostra umanità. Senza dialogo la società è come avvolta nel silenzio della tomba».
Partendo da queste premesse, fin dai primi anni settanta Ikeda ha iniziato una serie di incontri con statisti, studiosi, “costruttori di pace”, premi Nobel per la Pace, artisti di tutto il mondo per avviare un processo di pace globale attraverso il dialogo. Molti di questi incontri sono diventati libri, tradotti nelle principali lingue del mondo e fonte di ispirazione per tante persone che desiderano realizzare la pace partendo dalle loro comunità di vita.
Nelakanta Radhakrishnan, presidente della Gandhi Smriti ha scritto: «Per me è chiaro che Ikeda sta portando a compimento alcuni concetti che Gandhi non ha potuto realizzare compiutamente. Più approfondisco il lavoro e il messaggio che Ikeda offre alle persone, più sono convinto che egli rappresenta una reale speranza per l’umanità sofferente.
Nell’ultimo dialogo con Gorbaciov egli ha detto: “Dobbiamo creare una società fondata sul dialogo che rispetti le differenze e accetti le diversità”. Daisaku Ikeda è un esempio di riformatore sociale moderno che ha saputo utilizzare l’infinito potenziale di una religione per costruire relazioni di amicizia e legami culturali tra le nazioni di tutto il mondo.
Insieme alla moglie Kaneko e ai membri della Soka Gakkai internazionale Ikeda continua a percorrere la strada del dialogo per la costruzione di un nuovo umanesimo che trascenda derive settarie, dogmatiche e fondamentaliste».
Molti dei sui dialoghi sono diventati libri tradotti in numerose lingue.
Per un elenco aggiornato dei dialoghi pubblicati in italiano https://esperiashop.it/it/
In questa sezione vengono indicati alcuni saggi scritti da Ikeda e tradotti in italiano.
Riproponiamo i capitoli pubblicati sulla rivista Buddismo e Società del libro Per il bene della pace. Sette sentieri verso l’armonia globale: una prospettiva buddista.
- Prefazione
- 1° Una prospettiva di pace
- 2° La via del dominio di sé
- 3° La strada del dialogo e della tolleranza
- 4.1° La via della comunità
- 4.2° La via della comunità
- 5.1° La via della cultura
- 5.2° I padroni del linguaggio
- 6° Il sentiero delle nazioni
- 7° Il sentiero della consapevolezza
- 8° Il sentiero del disarmo
Altri titoli:
- La Saggezza del Sutra del Loto vol. 1,2,3. Tramite una serie di dialoghi che esaminano i profondi significati simbolici del Sutra del Loto, Ikeda offre un’interpretazione attuale e concreta di questo testo, che si rivela un insegnamento chiave per aprire nuove prospettive al genere umano all’alba del terzo millennio.Nel primo volume vengono presi in esame i capitoli che vanno dal primo (Introduzione) all’undicesimo (L’apparizione della Torre preziosa). Nel secondo volume affronta i temi presenti nei capitoli dal dodicesimo al sedicesimo. Tra questi la predizione dell’illuminazione per gli esseri malvagie per le donne, mai considerata possibile nei sutra precedenti. Nel terzo volume affronta i capitoli dal diciassettesimo al ventottesimo. Particolare risalto assumono la figura del Bodhisattva Mai Sprezzante, che rappresenta il modello ideale del discepolo del Budda dedito a diffonderne la parola, e la cerimonia di affidamento, con la quale il Budda conferisce a tutti i discepoli la missione di propagare il suo insegnamento nelle epoche future.
- La vita mistero prezioso Daisaku Ikeda rifacendosi alle lezioni del Budda Shakyamuni intraprende l’esplorazione della natura e della forza vitale che muove il cosmo e gli individui, e le tre sezioni in cui si articola il libro sviscerano ogni aspetto del problema: l’apparente contrapposizione tra spirito e materia; le infinite possibilità dell’esistenza umana; infine l’ineluttabilità della morte e il suo valore in rapporto alla vita. Partendo dalle moderne soluzioni scientifiche e considerando le risposte cui sono giunte le filosofie occidentali e orientali, è negli insegnamenti del Budda che l’autore individua la più autentica indicazione circa la via che l’uomo contemporaneo deve intraprendere per conseguire la vera dignità dell’esistenza.
- I misteri di nascita e morte, la visione buddista della vita Il Buddismo di Nichiren, benché risalente a oltre settecento anni, fa propone una validissima ricetta per il senso d’impotenza e la disperazione che oggi pervadono la società. Il destino, ovviamente, non sempre si rivela in accordo con i nostri desideri, ma il Buddismo, e specialmente il Buddismo di Nichiren, ci consente di sviluppare il potere necessario per trasformarlo.
- Gioia nella vita e gioia nella morte, affrotare le quattro sofferenze Secondo gli insegnamenti del Buddismo gli esseri umani pososno assaporare la gia sia nella vita che nella morte se attingono alla particolare condizione vitale chiamata Buddità. Ikeda frronta le questioni fondamentali della via dialogando con alcuni medici e infermieri.
- La religione della rivoluzione umana In questo volume sono raccolte dodici lezioni della serie “Il Buddismo del sole”. Il Maestro Ikeda delinea il profilo di una religione autenticamente umanistica, capace di permettere a ogni persona di rivoluzionare la propria condizione vitale e di contribuire a un cambiamento positivo della società, influenzando il destino dell’intera umanità. Vengono affrontati princìpi cardine del Buddismo partendo dagli scritti del Daishonin.
- La vita del Budda Interpretazione della vita e delle scelte del Budda Shakyamuni.
- Buddismo il primo millennio Il volume affronta lo sviluppo del Buddismo dopo la morte del suo fondatore. A partire dal primo concilio, organizzato dai discepoli diretti di Shakyamuni, che mise ordine nel complesso sistema degli insegnamenti del Budda, fino alla nascita del movimento Mahayana, le cui origini restano poco definite. Daisaku Ikeda esamina le scarse notizie storiche giunte sino a noi ed espone i principi essenziali del Sutra del Loto e ripercorre le vicende di alcuni protagonisti della storia del Buddismo: il re Ashoka e i filosofi Nagarjuna e Vasubandhu, che contribuirono alla sua affermazione come una delle principali religioni mondiali.
- Buddismo in Cina Storia della diffusione del buddismo in Cina e cronaca dell’incontro tra due grandi civiltà asiatiche quella dell?India dove nacque l’insegnamento e quella della Cina dove il buddismo si trasformò in una religione universale e da cui gli insegnamenti vennero tramandati in Corea e Giappone.
L’educazione Soka Nel volume Daisaku Ikeda esamina il pensiero pedagogico di Tsunesaburo Makiguchi, pioniere dell’educazione creativa, e sviluppa il tema della formazione di una coscienza globale nei giovani e il dialogo e lo scambio come preziose opportunità di arricchimento per ogni persona.
Questa sezione è dedicata ai testi delle conferenze che Daisaku Ikeda ha tenuto dal 1975 al 1995 presso università, istituti di ricerca e accademie in tutto il mondo (raccolti nel volume Un Nuovo Umanesimo edito dalla casa editrice Esperia, 2004, Milano).
I testi di queste conferenze mirano alla creazione di una società che valorizzi l’individuo e le sue infinite potenzialità nel mondo di fine millennio, alla ricerca di nuovi equilibri.
Daisaku Ikeda cerca di creare legami, ponti di amicizia e comprensione nello sforzo costante di superare la diffidenza che divide l’Occidente dall’Oriente, una nazione dall’altra esplorando il patrimonio lasciato in eredità al genere umano dai grandi pensatori.
Prendendo a prestito le parole di personaggi del calibro di Tolstoj, Gandhi, Leonardo da Vinci, Pascal o dei saggi dell’antica Cina, Ikeda coglie i punti in comune tra le diverse culture e esalta le caratteristiche peculiari di ogni popolo.
PARTE PRIMA: ARTE, LETTERATURA ED EDUCAZIONE
Accademia delle Belle Arti dell’Institut de France, Parigi, 14 giugno 1989
L’arte, come la religione, rappresenta il legame dell’individuo con la realtà fondamentale e il punto di partenza per la rinascita del genere umano. L’arte è un processo collegato all’essenza stessa della vita, intesa come tensione dinamica in cui si opera una profonda fusione tra l’“io” (il microcosmo) e “l’universo” (il macrocosmo). È da tale “realtà fondamentale” che l’essere umano attinge energia per il proprio rinnovamento: qui egli trova una ragione di essere e il cardine della propria ricerca. (…)
Università di Ankara, Turchia, 24 giugno 1992
Molto più di un semplice processo di occidentalizzazione, il kemalismo è il prodotto di una terra, la Turchia, che è punto di incontro tra Est e Ovest. L’apertura mentale e l’aspirazione all’universalismo sono le correnti che fluiscono nella profondità della struttura istituzionale di questo movimento. Il punto forte della rivoluzione kemalista è stato l’intervento educativo, strumento fondamentale per la creazione di una nuova Turchia (…)
Università di Pechino, 28 maggio 1990
L’educazione è la forza fondamentale che costruisce la società e forgia un’epoca, alimenta e forma l’infinito potenziale che alberga in ognuno di noi e dirige la nostra energia verso la creazione di valore (…)
Università delle Filippine, 10 aprile 1991
Il termine bayanihan, che significa “aiuto reciproco nella comunità”, esprime lo spirito tradizionale delle Filippine, uno spirito che dovrebbe diventare patrimonio di tutta l’umanità. Daisaku Ikeda porge le sue scuse – come cittadino giapponese – al popolo filippino per le atrocità commesse dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale (…)
Università di Bologna, 1° giugno 1994
La formazione di un nuovo e globale sistema imperniato sull’ONU dipende da quanti “cittadini del mondo”, in grado di sostenerlo, possano crescere e svilupparsi. Mai come in quest’epoca, immersa nei gravi problemi di fine secolo, l’umanità ha bisogno di un patrimonio spirituale come quello di Leonardo Da Vinci, genio cosmopolita del Rinascimento italiano, il cui sguardo universale sul mondo fu animato da un vero umanesimo cosmico (…)
Università M.V. Lomonosov, Mosca, 17 maggio 1994
Occorre che l’essere umano sia posto al centro di tutto, e che le persone diventino indipendenti spiritualmente, risvegliandosi alla realtà fondamentale della vita. Allo stesso tempo, è necessario allargare la nostra vita per comprendere l’universo, per rivitalizzare e coltivare il nostro dinamismo interiore (…)
PARTE SECONDA: DIMENSIONI DELLA CULTURA
Università M. V. Lomonosov, Mosca, 27 maggio 1975
La letteratura russa si è sviluppata all’unisono con il desiderio di felicità, libertà e pace delle persone comuni; non sarebbe potuta nascere separata dal popolo e senza una profonda comprensione della natura umana. In tempi come quelli attuali, in cui urge l’unità a livello mondiale, questo spirito della cultura russa deve diventare una forza ispiratrice per tutti i popoli, e contribuire alla qualità degli scambi culturali nel XXI secolo, nella costruzione di una Via della Seta spirituale che unisca i cuori dei popoli di Oriente e Occidente (…)
Università di Guadalajara, Messico, 5 marzo 1981
Lo spirito poetico, il sorriso, l’empatia sono indispensabili per stabilire buone relazioni umane e realizzare la pace. L’anima del popolo messicano, mai vinto in tre secoli di oppressione coloniale, si è fortificata nell’esperienza della rivoluzione e può quindi offrire un grande contributo alla pace. Il Buddismo spiega il legame profondo che unisce tutti gli esseri viventi tra loro e con il loro ambiente. È tempo che tutte le nazioni e i popoli riconoscano e valorizzino questo legame (…)
Università Saint Kliment Ohridsky, Sofia, Bulgaria, 21 maggio 1981
Il futuro dello spirito nazionale della Bulgaria dipende dalla saggezza dei suoi cittadini. Le barriere che separano le nazioni saranno sicuramente superate, aprendo la via verso una umanistica società globale del XXI secolo. Il leone, simbolo della Bulgaria, ha un significato profondo anche nel Buddismo: il re Ashoka fece erigere una stele con quattro leoni nel luogo dove il Budda aveva esposto per la prima volta il Dharma. Il leone è il simbolo dell’insegnamento del Budda che arriva al cuore della gente (…)
Università Bucarest, Romania, 7 giugno 1983
Dietro il concetto di stato nazionale si cela una cultura umana infinitamente varia, fondata su migliaia di anni di storia e tradizioni. Per realizzare l’ideale di un mondo unificato è importante riconoscere valori spirituali universali che leghino fra loro le tradizioni culturali a livello locale e permettano allo stesso tempo a ciascuna di brillare di luce propria. Mircea Eliade, uno dei più grandi filosofi della religione di questo secolo, nato in Romania, nutriva la speranza che l’incontro tra le popolazioni dell’Occidente moderno con il mondo non occidentale facesse emergere un nuovo umanesimo (…)
Università di Macao, Cina, 30 gennaio 1991
Tremila anni di storia della Cina sono permeati dal senso di armonia, una «innata consapevolezza» e sensibilità che portano allo spirito umano ordine e prospettiva cosmopolita. Questa spiritualità, unica nel suo genere, è evidente sia nel Buddismo cinese sia in quello mahayana giapponese. Anche le cinque virtù cardinali della filosofia confuciana – gentilezza, rettitudine, decoro, giudizio e lealtà –, se interpretate alla luce di questa grande tradizione cinese, si rivitalizzano e assumono un nuovo significato come linee guida per il XXI secolo (…)
Università Fudan, Shangai, Cina, 9 giugno 1984
Pochi sono i paesi che possono eguagliare la Cina nella profondità del suo interesse per la storia, tradizionalmente considerata il nutrimento che alimenta la vita e gli esseri umani perché sostiene la creazione di un presente e un futuro migliori. Se la storia è utilizzata per scrutare il destino degli esseri umani, la cronaca degli eventi passati non può rimanere indipendente da loro ma ne deve essere coinvolta. Oggi, per quanto gli eventi possano essere imprevedibili, dobbiamo imparare a considerare la storia come un dramma in cui le persone ricoprono un ruolo decisivo e sviluppare una solidarietà degna di cittadini di uno stesso mondo (…)
PARTE TERZA: LA RELIGIONE E IL NOSTRO TEMPO
Università di Pechino, 22 aprile 1980
Nessuna idea nella cultura cinese può essere ricondotta a un concetto giudaico-cristiano o islamico di Dio. La sua visione degli esseri umani e del mondo è «una visione dell’universale alla luce del particolare»: in base a questa tendenza i cinesi non hanno fatto ricorso a mediazioni come il monoteismo, ma sono riusciti a desumere direttamente dalla realtà profondi principi di validità universale. Uno degli elementi più raffinati dell’eredità spirituale della Cina è la convinzione che un individuo si debba confrontare direttamente con la realtà e, su questa base, decidere come meglio ricostruirla (…)
California University, Los Angeles, 1° aprile 1974
In ogni essere umano c’è un “piccolo io” e un “sé eterno e universale”. Cadere in preda ai desideri ed essere incapace di controllarli significa vivere per soddisfare il “piccolo io”. Vivere per il “sé eterno” vuol dire conoscere il principio universale che sottende ogni cosa e risvegliarsi a ciò che esiste al di là dei fenomeni transitori. Il “sé eterno” è il principio fondamentale che regola tutto l’universo (…)
Museo Nazionale dell’India, Nuova Delhi, 11 febbraio 1992
Gandhi credeva nell’immenso potere spirituale e religioso di ognuno di noi. Credeva inoltre che questa profonda sorgente di energia e di forza non dovesse rimanere assopita, ma essere risvegliata e utilizzata. Non riconoscendo “altro Dio che la Verità” e restando fermo nel suo rifiuto del settarismo, Gandhi manifestava una grande forza spirituale. Questa stessa spiritualità guarirà e rivitalizzerà i cuori e le menti degli esseri umani feriti dalle ideologie violente del nostro tempo (…)
Accademia cinese delle Scienze Sociali, Pechino, 14 ottobre 1992
Nel XXI secolo il mondo dovrà prestare sempre più attenzione non solo alle capacità economiche dell’Est asiatico, ma soprattutto alla sua profonda tradizione spirituale. Questa regione del pianeta diventerà una forza guida nella storia, una sorgente di speranza per tutte le persone (…)
Harvard University, Cambridge, Usa, 24 settembre 1993
Al Buddismo mahayana spetta un ruolo importante nel cammino della civiltà umana verso il XXI secolo. Tre i punti chiave: la tradizionale propensione buddista alla nonviolenza e al dialogo, la ricerca di un equilibrio tra le forze individuali e tutto ciò che esiste al di là di esse e la relazione che unisce profondamente ogni individuo a tutte le altre forme di vita esistenti (…)
Claremont McKenna College, Usa, 29 gennaio 1993
Come il radicalismo è destinato per natura a ricorrere alla violenza e al terrore, così lo strumento più potente dell’approccio gradualista è il dialogo. L’armonia umana può essere sostenuta soltanto nell’ambito dello spazio aperto creato dal dialogo condotto con i nostri simili, con la storia, con la natura e l’universo, anche allo scopo di recuperare la totalità e l’unità dell’esperienza umana così disastrosamente erosa da un’accelerata frammentazione del sapere (…)
PARTE QUARTA: L’IMPERATIVO DELLA PACE
Università Shenzhen, Guangdong, Cina, 31 gennaio 1994
In quest’epoca di crepuscolo degli dei, sembra appropriato cercare «un concetto di moralità, un modello etico che non sia mai stato sostenuto da sanzioni da parte del sovrannaturale»; a questo riguardo la cultura cinese può offrire un inestimabile dono al mondo (Joseph Needham). La forza morale umanista che la Cina ha accumulato lungo la sua storia, il suo spirito fondato sulla fiducia in sé, sull’autodisciplina e sul personale miglioramento sono forse destinati a dare pace non solo alla metà, ma al mondo intero (Arnold Toynbee) (…)
Accademia delle Lettere del Brasile, Rio de Janeiro, 12 febbraio 1993
Il Brasile, democrazia caratterizzata da diversità etnica, è un prezioso esempio per il futuro e un antidoto per eventi che tendono alla divisione. Il temperamento dei brasiliani, contraddistinto da apertura mentale, gentilezza, ospitalità e generosità di spirito, trae la propria origine spirituale dal senso di universalità e disponibilità verso la vita e l’universo. Ma i frutti del grande universalismo di questo paese potranno essere raccolti soltanto quando ci sarà quella tensione tra universalismo e particolarismo verso cui il Buddismo mahayana ci orienta (…)
Università di Buenos Aires, Argentina, 1° marzo 1990
Oggi si sta delineando una grande transizione e non è più possibile per nessuno stato o regime perseverare in una politica di isolazionismo. La principale sfida che affrontiamo all’alba del XXI secolo è di cambiare marcia e trovare un modo per armonizzare il nazionalismo con il globalismo. L’Argentina presenta delle straordinarie diversità geografiche ed etniche. L’emersione dell’individuo cosmopolita rappresenta quel genere di trasformazione necessaria per il futuro: ecco perché considero l’Argentina lo stato precursore del nuovo globalismo (…)
John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Usa, 26 settembre 1991
Le energie generate nell’essere umano dall’impulso di creare benessere per l’umanità possono diventare le basi per un nuovo tipo di potere: quello che si fonda sul dialogo, sul rispetto per la vita e sull’autocontrollo. Un “potere morbido” da contrapporre al “duro” prevalere della guerra e della violenza (…)
interviste a daisaku Ikeda
Intervista a Daisaku Ikeda di Clark Strand
daisaku ikeda
Visita il sito ufficiale (in inglese). Qui troverai dettagli sul suo contributo alla diffusione della pace e dell’empowerment individuale, insieme a una vasta selezione di scritti, discorsi e iniziative educative.